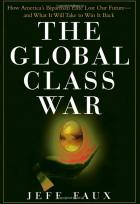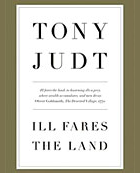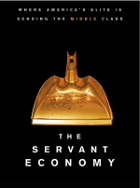Sottotitolo:
Lo statuto è una legge sulle due cittadinanze: quella collettiva e quella individuale. Non si limita a fare entrare il sindacato nell’impresa, ma ridisegna l’immagine dell’individuo con le sue istanze di auto-determinazione anche di fronte al sindacato.
A lezione, raccontavo che il sindacato assomiglia al centauro della leggenda: metà uomo e metà cavallo. Un giorno, uno studente m’interruppe per domandarmi: “cosa succede quando il sindacato accusa qualche malessere? conviene chiamare il medico o il veterinario?”. La domanda era sensata. Me la cavai dicendo: “il problema non si pone. A dargli retta, il sindacato sta sempre benone. Perlomeno, non ha mai comunicato di avere bisogno di cure”.
Curioso e stravagante, l’accostamento non è tuttavia arbitrario.
La “bipolarità del sindacato come libero soggetto di autotutela in una sfera di diritto privato e, nello stesso tempo, soggetto di una funzione pubblica è presente nella stessa costituzione”. Parola di padre costituente: si chiamava Vittorio Foa.
In effetti, testo costituzionale alla mano, la legittimazione del sindacato a sottoscrivere contratti collettivi provvisti di una generale efficacia vincolante – il che basta e avanza per attribuirgli un ruolo da legislatore privato – si lega all’affidabilità democratica della sua dinamica associativa e la quota di potere contrattuale che gli spetta nell’organismo unitario di negoziazione ipotizzato nell’ultimo comma dell’art. 39 è proporzionata al numero degli iscritti. Come dire che la fonte del potere contrattuale del sindacato risiede comunque nella sua membership. Non senza sorpresa. E ciò perché, secondo la premessa stipulativa accolta dai padri costituenti, nel codice genetico del sindacato la componente pubblico-istituzionale si coniuga con quella associativa, cosicché un sindacato polarizzato su di una sola di esse non è un minus né un plus: è un aliud.
Ad ogni modo, i corollari ricavabili dalla norma costituzionale, se analizzata col microscopio, sono i seguenti:
a) il prodotto più caratteristico dell’azione sindacale ha l’aspetto esteriore di un contratto e l’anima della legge;
b) il sindacato si qualifica come un rappresentante sui generis, perché agisce nella veste più di un tutore incaricato di un munus publicum che di un mandatario provvisto della procura rilasciata dai diretti interessati.
c) Visto che il contratto collettivo si applica ad una platea composta di rappresentati e assistiti in senso tecnico, dove i secondi sovrastano numericamente i primi, anche i senza-tessera sono dei soggetti sui generis. Come un celebre personaggio di Italo Calvino, sono dei soggetti dimezzati perché hanno una capacità d’agire limitata e difatti lo stesso sindacato finisce per trattarli come bisognosi di un’autorità tutoria.
Sennonché, l’analisi dell’enunciato costituzionale mette in evidenza che il problema della democratizzazione del potere para-legislativo di questo rappresentante sui generis è ineludibile. Alla fin dei conti, la garanzia di democraticità del funzionamento di quella che per i non-iscritti è un’istituzione esterna, un altro-da-sé, risiederebbe essenzialmente nell’intensità (ampiezza, incisività) della partecipazione degli associati ai processi decisionali e nell’efficienza dei controlli interni sulle decisioni adottate. Non è molto, ma è tutto e sparirebbe se il sindacato fosse, come di solito è, un’associazione più virtuale che virtuosa.
Quindi, non si manca di rispetto verso i padri costituenti riconoscendo che la sola garanzia di democraticità del potere sindacale su cui possano contare i non-iscritti è troppo fragile per non ravvisarvi una forma di irenismo costituzionale. Può darsi che sia scusabile. Dopotutto, era la prima volta nella storia dell’Italia unita che veniva definito l’assetto sindacale in un regime democratico e l’Assemblea costituente si sforzò di escogitare una soluzione originale. Ciò non toglie che la natura complessa dell’ibridazione da cui trae origine il sindacato apra questioni di non facile soluzione.
Fatto sta che finora nessuno ha chiarito come possano coesistere, nel DNA del sindacato, la componente pubblico-istituzionale e quella associativa: stabilendo un intreccio o semplicemente sovrapponendosi, o che altro? Del pari, c’è da chiedersi su cosa possa fondarsi la fiducia che la bipolarità avrebbe trovato spontaneamente l’equilibrio necessario per procurare al sindacato le risorse che impediscono al diritto pubblico di catturarlo nello stesso momento in cui lo predispone a subirne l’attrazione. Non a caso, è anche (e forse soprattutto) per questi motivi che l’art. 39 non ha avuto attuazione. Può darsi che la libertà sindacale costituzionalmente protetta sia stata conservata proprio in virtù dell’inadempienza costituzionale, perché nel dopo-costituzione il rischio di una legislazione intrusiva e sostanzialmente anti-sindacale era nelle cose. Nondimeno, è intellettualmente onesto prendere atto che per questa via si è silenziosamente formata una situazione di singolare a-legalità costituzionale e che essa è stata metabolizzata anche dagli autori dello statuto dei lavoratori. Una situazione che nemmeno il referendum del 1995 sull’art. 19 ha corretto.
L’esito referendario ha soltanto proibito che si continuasse a premiare la rappresentatività sindacale valutandola pigramente al livello più alto possibile di centralizzazione burocratica, dove la logica dell’istituzione in bilico tra pubblico e privato soverchia quella tipica dell’associazione di diritto privato. Pur abbassando al livello aziendale la valutazione della rappresentatività, il legislatore popolare è rimasto lontano mille miglia dall’obiettivo di accertarla e misurarla, come richiesto da una sentenza pronunciata nel 1990 dalla Corte costituzionale, in base a “regole ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato”. Infatti, gli stessi addetti all’unità produttiva che hanno preso l’iniziativa di costituirvi l’organismo di rappresentanza non possono tuttora disporre degli strumenti di democrazia diretta (pur previsti dallo statuto, come l’assemblea e il referendum) per compiere verifiche di mandato – un mandato più politico in senso lato che associativo in senso stretto. Aveva quindi ragione Massimo D’Antona a sottolineare in un saggio del 1990 l’incompiutezza dello statuto: “il tit. III dello statuto è una legge sulla cittadinanza del sindacato in azienda che si preoccupa delle garanzie dei rappresentanti di fronte al potere dell’impresa, ma non definisce la posizione dei rappresentati nei confronti dei medesimi”.
Nel suo insieme, però, lo statuto è una legge sulle due cittadinanze. Quella collettiva e quella individuale. Del gruppo organizzato e del singolo in quanto tale. Infatti, discostandosi dalla tradizionale cultura del rapporto di lavoro come rapporto di mercato, lo statuto si dissocia simultaneamente anche dall’eresia giuridica formatasi nella prima modernità: quando, come scrive Ulrich Beck, “dominava la figura del cittadino-lavoratore con l’accento non tanto sul cittadino quanto sul lavoratore”.
Lo statuto, insomma, non si limita a fare entrare il sindacato nell’impresa. Ridisegna l’immagine dell’individuo con le sue istanze di auto-determinazione di fronte ad ogni potere, anche il più protettivo e benevolo. Per questo, intende sanare la contraddizione che vede dei cittadini attivi nel governo della polis tornare allo stato di sudditi nel luogo di lavoro di fronte alle autorità che vi hanno giurisdizione e dunque tanto di fronte al datore di lavoro quanto di fronte al sindacato: al quale il singolo non è necessariamente iscritto e che, pur tuttavia, concorre a co-determinare le sue condizioni di vita stipulando contratti collettivi applicabili de facto o de iure anche a lui.
Come dire che lo statuto sfida tanto l’impresa quanto il sindacato a rilegittimarsi adeguando i rispettivi principi d’azione ai valori di cui è portatore un cittadino anche quando lavora. Anzi, dal momento che “il diritto dell’individuo di essere informato, consultato, abilitato ad esprimersi nella formazione delle decisioni che riguardano il suo lavoro” simboleggia la trama dei diritti che avvolge la trentiniana Città del lavoro, a rigore bisognerebbe concludere che esso è esigibile anzitutto nei confronti del sindacato nella sua qualità di centro privato di (co) produzione delle regole del lavoro. Il che inter alia significa che l’obbligatorietà generalizzata del contratto collettivo è legittimata dal consenso maggioritario dei destinatari finali del medesimo.
Fa perciò un certo effetto che l’esigenza di coinvolgere direttamente i lavoratori nella fase di formazione delle normative pattizie sia schizzata a galla per iniziativa di un datore di lavoro; un’iniziativa oggettivamente inquinante. Ma fa un effetto ancora peggiore che la medesima esigenza sia stata in qualche modo percepita da un legislatore in preda a distruttivi deliri che abilita la contrattazione collettiva c.d. di prossimità a peggiorare standard protettivi di generale applicazione.
Diciamo la verità: sia la vicenda del ricatto occupazionale posto in essere dalla Fiat nel 2010 sia il carattere emergenziale e l’intento penalizzante dell’art. 8 della legge 148 del 2011 danno la misura della distanza che separa la realtà giuridico-sindacale da come era stata annunciata. “Il disegno di legge che il mio ministero sta elaborando”, aveva detto Giacomo Brodolini, “si propone di fare del luogo di lavoro la sede della partecipazione democratica alla vita associativa sindacale e della formazione di canali democratici tra il sindacato e la base”.
Pertanto, se le sorti delle due cittadinanze garantite dallo statuto hanno potuto divaricarsi; se l’esperienza applicativa dello statuto ha potuto sbilanciarsi a vantaggio dell’autoreferenzialità del collettivo organizzato cui corrisponde la subalternità dell’individuale; se il sindacato ha potuto maturare una concezione proprietaria della contrattazione collettiva, ebbene ciò è successo perché il discorso sindacale non conosce ancora la grammatica e la sintassi più adatte a valorizzare la figura del lavoratore in quanto cittadino. Il suo linguaggio è quello impoverito dall’abitudine di rappresentare il cittadino in quanto lavoratore; un’abitudine sulla quale il riposizionamento del lavoro nelle zone alpine del diritto costituzionale è rimasto ininfluente.
E’ importante, mi sembra, acquisire questa consapevolezza in un momento in cui nessuno è in grado di pronosticare il futuro del sindacato nell’Occidente europeo. E’ importante perché dà almeno la certezza che il sindacato un futuro non lo avrà se non farà il pieno di democrazia.