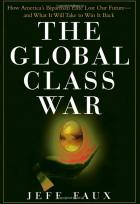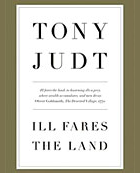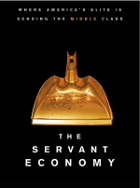Sottotitolo:
L’élite politico-tecnocratica che è alla testa dell’eurozona, mescolando austerità e riforme strutturali, accresce la disoccupazione di massa e, inevitabilmente, cancella le prospettive di lavoro per i giovani. E, al tempo stesso, alimenta la truffa della contrapposizione tra “insider” e “outsider”.
Il governo italiano, i giornali e la televisione non avevano mai prestato tanta attenzione alla disoccupazione giovanile. Un fatto positivo e apprezzabile in sé, poiché non è buona consuetudine in questi anni di crisi sottolinearne le conseguenze sociali, la mancanza di lavoro, l’impoverimento crescente di chi lavora con salari sempre più bassi, di chi il lavoro l’ha perduto, di chi non lo trova, e fra questi un esercito di giovani.
Ma l’ apprezzamento per questa insistita attenzione si ferma qui. Anzi l‘apprezzamento si trasforma in indignazione, quando constatiamo che l’argomento dei giovani disoccupati è utilizzato cinicamente per sviare il discorso sul modo come si sta affrontando la crisi. O, se si vuole, come si sta adoperando la crisi per una battaglia sociale che aggrava la diseguaglianza, colpisce gli strati più deboli della popolazione, utilizza la disoccupazione come strumento per le famigerate riforme di struttura che hanno come obiettivo principale la riduzione delle tutele sociali e ciò che rimane del diritto del lavoro, eredità del secolo scorso.
Quando la crisi deflagrò nel 2008 in America, fu immediatamente paragonata a quella del 1929. Un paragone allarmante che richiamava un’epoca infelice, la Grande Depressione, la miseria di grandi masse in America, e per di più in Europa l’avvento di nuovi fascismi. E, tuttavia, quel paragone comportava anche un elemento di speranza, se non di rassicurazione. Mentre, infatti, nell’autunno del 2008, si consumava l’atto più emblematico della crisi con il collasso della Lehman Brothers, si avviava alla conquista della presidenza Barack Obama, un democratico che, di là a qualche settimana, avrebbe posto fine all’infausta presidenza di George Bush. l’America aveva cacciato se stessa e il resto del mondo nella crisi, ma avrebbe potuto indicare la strada per uscirne. Invece, quattro anni dopo siamo al punto di prima, anzi, soprattutto in Europa, molto peggio di prima.
Cosa è successo, cosa è andato storto? Perché oggi siamo costretti a ragionare dell’aumento della disoccupazione in tutta l’Europa e della recessione che paralizza la Spagna e l’Italia, per non parlare della Grecia e del Portogallo? Quando si mette l’accento sul fatto che un terzo dei giovani è in Italia disoccupato si indica un problema allarmante, ma si oscura il quadro nel quale quel problema si colloca, talvolta armati di buone intenzioni, ma talaltra in evidente malafede. Se siamo in recessione, se centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che erano occupati perdono il lavoro, come sta accadendo ancora in questi mesi, se altre centinaia di migliaia vivono in una precaria cassa integrazione con poche o nessuna speranza di riassorbimento, c’è qualcosa di drammaticamente sbagliato e inaccettabile nello scenario economico e politico generale all’interno del quale si pone la questione dei giovani. Se la isoliamo rischiamo di vedere l’albero e non la foresta.
*****************
Proviamo a tornare ai primi passi della crisi. Proprio sulla base dell’esperienza del ‘29 bisognava impedire che l’innesco desse luogo a un incendio incontrollabile come allora era successo in America, e poi in Europa. Negli Stati Uniti furono subito prese le misure per bloccare la crisi bancaria. Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, era un profondo conoscitore della crisi bancaria dl del ‘29 ed era convinto, sulla scia di Milton Friedman, che l’errore più grave era consistito nella politica restrittiva che aveva essiccato la liquidità e messo in crisi l’intero sistema finanziario. Bisognava evitare questa deriva. E, infatti, furono prese tutte le misure per rifornire di illimitata liquidità le grandi banche. C’è chi ha affermato che la Lehman fu lasciata fallire scientemente per creare una situazione di emergenza e di panico che, in effetti, portò il Congresso americano, che si era dimostrato riluttante, ad approvare nel giro di qualche giorno oltre 700 miliardi a disposizione del governo, che era ancora quello di Bush, per un risoluto salvataggio del sistema bancario.
L’incendio era domato. Ma non bastava rispetto alla caduta della produzione, e all’aumento a vista d’occhio della disoccupazione che, dal 4,5 per cento marciava rapidamente verso il 10 per cento, creando otto milioni di nuovi disoccupati. Spettava a Barack Obama, insediatosi all’inizio de 2008 alla Casa Bianca dare un inequivocabile segnale di svolta. Se, per continuare il confronto con la crisi del ’29, erano passati tre terribili anni, quando Franklin D.Roosevelt assunse la presidenza nell’inverno del ’33, Obama aveva assunto la presidenza solo tre mesi dopo il punto di non ritorno costituito dal crack della Lehman.
Gli effetti nefasti de ’29 potevano essere ancora scongiurati e, infatti, Il nuovo presidente suscitò grandi speranze. Disse subito che bisognava non fermarsi al salvataggio delle banche, ma intervenire sull’economia reale per rilanciare la crescita e l’occupazione. E indicò un ambizioso programma di investimenti pubblici, di cui sottolineò il ritardo e un assoluto bisogno: dal sistema dei trasporti, alle fonti energetiche rinnovabili, ad alcuni settori industriali in bancarotta come l’auto, alla ricerca e alla scuola. Spiccava in questo programma la madre di tutte le riforme sociali che in America è sempre stata la riforma sanitaria, fra tutte di gran lunga la più ardua e controversa. A sostegno del programma, Obama chiese e ottenne dal Congresso la disponibilità di quasi 800 miliardi di dollari, appunto con l’obiettivo del rilancio della crescita e della lotta alla disoccupazione. Per fare un confronto, è come se in Italia Passera avesse a disposizione all’incirca 80 miliardi di euro per un programma di rilancio della crescita e dell’occupazione.
Ma, quella che nelle miserie dell’attuale politica europea, a noi potrebbe sembrare un’operazione miracolosa, si dimostrò insufficiente. A giudizio degli economisti americani di parte progressista sarebbe stato necessario un impiego di risorse molto più energica, da un minimo di 1200 a 2000 miliardi di dollari. Il rilancio fu, infatti, insufficiente e la disoccupazione continuò a crescere. Le elezioni di mezzo termine andarono male per i democratici che persero la maggioranza nella Camera dei Rappresentanti. Insomma, la politica monetaria iper-espansiva della Federal Reserve aveva riportato in auge il sistema bancario, ma non era stata la leva sufficiente per rilanciare gli investimenti pubblici, dare gambe concreta all’ambizioso programma del presidente. Quella che sembrava una politica di coraggiosa impronta keynesiana era stata evocata ma non portata a compimento.
Secondo i democratici americani di parte liberal e gli economisti come Stiglitz o Krugman, Barack Obama ha così perduto una grande occasione per timidezza, o per aver ceduto alle sirene moderate del centrismo, circondandosi di consiglieri che provenivano dall’esperienza discutibile di Bill Clinton, come Summers e Rubin. E, indubbiamente, hanno avuto ragione, considerato che, avvicinandoci alla fine del primo mandato, le speranze riposte in Obama sono andate in larga misura deluse e che, addirittura, la sua rielezione di novembre si presenta a rischio.
****************
Proviamo a cambiare prospettiva e a calarci nel quadro della crisi europea. Se, nel famoso film di King Vidor il “Passaggio a Nordovest” si era rivelato una missione incompiuta, come incompiuto si è rivelato il superamento della crisi tentato da Obama, il film a cui assistiamo nell’eurozona, può essere definito un film dell’orrore. A partire dalla crisi greca, tutto è stato fatto per spingere una crisi inizialmente controllabile verso una generale catastrofe sociale.
Non c’era nessuna ragione di massacrare la Grecia, dal momento che Papandreu aveva svelato gli imbrogli del precedente governo conservatore, peraltro certamente conosciuti dalle autorità europee, e aveva dichiarato di voler concordare una soluzione. Ma c’era bisogno di tempo e non gli fu concesso, fino a ottenerne le dimissioni, per mettere al suo posto un vecchio esponente della BCE. La Grecia aveva un debito inferiore al 120 per cento italiano e, sottoposta alla esiziale cura di Bruxelles, tre anni dopo il debito è salito al 160 per cento. Frattanto il popolo greco è ridotto alla fame e la disoccupazione ha superato il il 20 per cento. Non si tratta di una politica solo sbagliata, ma stupidamente punitiva. Sappiamo quale è stato l’effetto domino di una politica non solo sbagliata, ma stupidamente punitiva: il rischio di sprofondamento della Spagna, la recessione in Italia, il probabile suicidio dell’euro.
Il film dell’orrore di eurolandia ha molte sequenze sconcertanti, alle quali ci ha abituato fino a farcele sembrare quasi naturali. Abbiamo visto la Federal Reserve negli Stati Uniti distribuire fiumi di danaro alle banche che hanno ripreso a fare profitti e a giocare al casinò dei derivati. Ma la Fed ha acquistato parti crescenti delle emissioni del debito pubblico, riducendo così i tassi di interesse ai livelli più bassi della storia americana. Prendiamo l’eurozona. Una volta assunto il controllo della BCE, Mario Draghi fa un’operazione analoga, offrendo 1000 miliardi di euro a tassi dell’uno per cento con scadenze a tre anni.
E’ un’operazione di tipo americano, mirata a fornire liquidità al sistema. Ma con una differenza fondamentale. I destinatari sono solo le banche che possono acquistare i titoli di stato, lucrando sulla differenza dei tassi: per le banche si tratta di un profitto immediato e per i bilanci pubblici una “tangente”. E questo è solo un episodio della sequenza che gli economisti definiscono la “trappola del debito”, l’accumulo di nuovo debito per pagare gli interessi sul vecchio e, di seguito, un nuovo aumento dei tassi.
Ma il film dell’orrore ha una logica inesorabile. Poiché il debito non diminuisce ma cresce, gli stati coinvolti in questo scenario senza senso debbono obbedire all’ingiunzione di sempre nuove misure di austerità. Un’altra parola dal senso stravolto, dal momento che non corrisponde a scelte di comportamenti razionali, ispirati a un’amministrazione oculata delle risorse disponibili, ma a misure autolesionistiche che peggiorano la condizione presente, condizionando negativamente le prospettive future.
E’ possibile che i signori di Berlino, Francoforte e Bruxelles ignorino questi dati di fatto? No, non è possibile. E infatti ammettono che dall’austerità non nasce la crescita. La quale è affidata all’altro lato della medaglia della politica europea: le “riforme di struttura”. Ecco che il cerchio si chiude. L’austerità deve insegnarci a vivere tagliando la spesa sociale: meno soldi ai pensionati, meno alla scuola, meno ai servizi pubblici, meno a salari e stipendi. Ma l’austerità è solo una lato della medaglia: l’altro lato non meno importante, anzi più importante a lungo termine, è rappresentato dalle riforme che, per l’appunto, si definiscono strutturali. E qui si colloca la centralità della liberalizzazione finale del mercato del lavoro, che ha nell’attacco all’articolo 18 l’emblema di una filosofia generale di deregolazione dei rapporti di lavoro.
*****************
Quella che si definisce flessibilità è stata già tutta messa in atto. L’ultimo passaggio è la libertà di licenziare e di regolare i salari al di fuori di un contesto generale e di solidarietà fornito dai contratti nazionali. E’ questo che chiedeva la famosa lettera della BCE al governo Berlusconi, chiaramente confezionata più a Roma che a Francoforte, e che il governo Monti ha preso l’impegno di realizzare. Naturalmente, questa potrebbe essere giudicata un’ interpretazione esasperata e faziosa della politica europea e dei suoi fedeli esecutori, o ispiratori, a livello nazionale. E, tutto sommato, potremmo sentirci sollevati, se lo fosse. Ma prendiamo un testimone che guarda dal di fuori, che conosce bene la politica americana, e vediamo come giudica la politica europea. Leggiamo cosa dice Robert Reich, già ministro del Lavoro dell’amministrazione Clinton a metà degli anni 90, che affida il suo commento al Financial Times, giornale difficilmente qualificabile di sinistra.
Scrive in premessa Reich che i salari reali negli Stati Uniti continuano a scendere e aggiunge: “Dopo l’inizio della recessione la quota del reddito nazionale andato ai profitti è aumentata nella misura in cui sono scesi quelli destinati alla forza lavoro. I profitti delle imprese sono ora al livello i più alto degli ultimo 45 anni”. Ma come stanno andando le cose in Europa? “ La signora Merkel – scrive Reich – non cede sulla politica di austerità. Continua a opporsi a un rilancio della crescita mediante la spesa pubblica...in nome dell’economia dell’austerità. Rimanendo contraria una ripresa della crescita attraverso un aumento della spesa… vuole, invece, ricreare la crescita con le “riforme strutturali” – mediante le quali presumibilmente intende dare alle imprese più libertà di assumere e licenziare, di spostare il lavoro verso i lavoratori con contratti temporanei e, in generale, deregolati …Questo è ovviamente il modello americano…che ha esaltato i profitti al tempo stesso che deprimeva i salari”.
Delle due, l’una: o Reich non sa di cosa parla, o ci ricorda con un linguaggio chiaro e conciso, di che pasta è fatta la politica che sta mettendo in ginocchio una parte della vecchia Europa. Non si tratta di un errore fatale. L’obiettivo è cambiare definitivamente il modello sociale europeo, , americanizzarlo, mettere tutto il potere nelle mani delle imprese, aggredire i diritti conquistati nel secolo scorso, così come in America tre decenni fa, al tempo di Reagan, fu dichiarata guerra alle conquiste del New Deal. La crisi deve essere posta al servizio di questa svolta.
*************
Mario Monti definisce le riforme sociali in corso i “compiti a casa” che l’Italia dovrebbe comunque eseguire, anche se non gli fossero imposti dalle autorità europee. In ogni caso, si tratta di compiti sbagliati e, contrariamente alle speranze del governo la loro esecuzione non placa i mercati finanziari. Le controriforme sociali non sono bastate all’Italia come non sono bastate alla Spagna.
E’ sufficiente ricordare come il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy, fedele esecutore dei dettati di Bruxelles ha, con un decreto legge consolidato il diritto ai licenziamenti individuali per ragioni economiche, anche se illegittimi, e al tempo stesso dato licenza alle imprese di ridurre il salario contrattuale, dopo aver ridoto le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici, ma nemmeno quest è bastato. E oggi la Spagna è in condizioni peggiori di come l’ha lasciata Zapatero. Ciò che possiamo afferamre con certezza è che i governi di destra, dalla Grecia al Portogallo, alla Spagna si sono messi al servizio della signora Merkel senza nessun altro risultato che mandare allo sbaraglio i loro paesi.Ed è questo il percorso sul quale è incamminato il governo Monti.
La riforma delle pensioni è stata un’assurdità con il suo prolungamento dell’età pensionabile fino alla soglia d 70 anni, e la questione di centinaia di migliaia di cosiddetti “esodati”, lavoratori e lavoratrici senza lavoro, senza pensione e senza tutele, è solo la punta dell’iceberg rispetto ai problemi che la riforma porrà negli anni avvenire. La facilitazione dei licenziamenti perseguita con lo svuotamento dell’articolo 18, mentre cresce la disoccupazione di massa, è un insensato tributo all’ideologia della deregolazione. Mentre, a sua volta, la restrizione della Cassa integrazione straordinaria è in contrasto con le politiche, più o meno esplicitamente, praticate in altri paesi europei, dove meccanismi di diversa natura contrattuali o amministrativi sono mirati a frenare i licenziamenti collettivi in casi di crisi aziendali.
L’esempio di maggiore successo ce lo offre la Germania che, pure, la crisi ha pesantemente colpito nei primi due anni. La situazione è stata fronteggiata con un accordo fra governo, imprese e sindacati all’insegna della parola d’ordine: non licenziare. Nelle imprese in crisi è stato ridotto l’orario di lavoro per tutti con la tecnica del Kurzarbeit e il parziale finanziamento pubblico delle ore non lavorate. Il risultato è stato la conservazione degli organici da parte delle imprese, un leggero aumento della disoccupazione per un anno e poi il suo rapido abbassamento al di sotto del livello pre-crisi, mentre l’occupazione è tornata crescere.
Come dire che la Germania impone all’Europa una cura autodistruttiva, ma lascia ai sindacati tedeschi la possibilità di assolvere al loro ruolo, individuando i meccanismi adatti alla difesa dell’occupazione. Per non parlare degli sviluppi della contrattazione collettiva, che negli ultimi mesi si è conclusa con aumenti salariali dal 4 al 6 per cento, a seconda della durata, nel più grande sindacato dei servizi, Verdi, come nel più grande sindacato industriale, l’IG Metall. Provate a fare un confronto con il presidente del Consiglio italiano che si schiera con Marchionne, protagonista dell’affossamento della Fiat e del più brutale degli attacchi alla contrattazione collettiva, all’autonomia e alla democrazia sindacale.Questo è il bilancio di un governo certamente, per così dire, dalla faccia pulita rispetto a quello che l’ha preceduto, ma perfino più coerentemente di destra. Oggi siamo a una svolta. La presa d’atto del fallimento politico della miscela “austerità-riforme di struttura” propone con forza la necessità di passare rapidamente al binomio rovesciato: occupazione e crescita nel quale la componente lavoro è anche la leva primaria della crescita.
Il piano per il lavoro di cui parla Gallino e al quale lavora la CGIL può essere declinato in vari modi. Ma per realizzarsi ha bisogno della disponibilità di risorse pubbliche consistenti e immediate. Senza affrontare questo punto, il piano rischia di rimanere un esercizio astratto. Comunque si voglia articolarlo, si tratta della mobilitazione di investimenti pubblici dotati di un’operatività e risultati a breve, in effetti, immediati. Per fare qualche esempio, investimenti nella manutenzione delle città, negli interventi ambientali, nel sostegno alle piccole e medie imprese che si impegnino ad accrescere l’occupazione, nella ricerca per fare spazio ai giovani ricercatori costretti a rifugiarsi all’estero, nella scuola, soprattutto nel Mezzogiorno, dove imperversa la piaga degli abbandoni. Un piano con una resa occupazionale immediata che è anche il fondamento della ripresa della domanda per rilanciare la crescita.
*************
Avendo preso spunto dalla disoccupazione dei giovani, dobbiamo rifuggire dall’ingannevole pubblicità che separa il problema dei giovani dal problema generale della disoccupazione che colpisce sempre di più tutti, insieme con i figli che cercano un lavoro i padri e le madri che il lavoro l’hanno perduto, o sono di fronte al rischio di perderlo. Da questo punto di vista, il problema della disoccupazione giovanile è un aspetto del problema generale. Un problema che non ha niente a che vedere con un’ulteriore deregolazione del mercato del lavoro. In America, dove il mercato del lavoro è il più selvaggiamente flessibile e i licenziamenti si fanno con un cenno , secondo gli ultimi sondaggi, il 37 per cento dei giovani diplomati è disoccupato e un altro 17 per cento non è statisticamente conteggiato fra i disoccupati, avendo rinunciato a cercare un lavoro per l’impossibilità di trovarlo. La maggior libertà di licenziamento non crea occupazione, dovrebbe essere ovvio, ma per questo governo è vero il contrario. Si dice che è un governo di tecnici; il guaio è che i tecnici quando si misurano con la politica cercano la loro legittimazione, che non è popolare, nei principi ideologici che li guidano, spesso interpretandoli nella peggiore versione fondamentalista.
Abbiamo sottolineato che un piano del lavoro, per rivelarsi efficace anche come leva della crescita, esige una politica di investimenti con effetti il più possibile immediati. Ma, per dare un impulso all’occupazione giovanile, è necessario predisporre anche un capitolo specifico di interventi. In altri termini, misure straordinarie che non solo nell’America del New Deal, ma che anche in Europa sono state adottate nelle fasi di maggiore difficoltà in quasi tutti i paesi dell’Unione a metà degli anni ottanta, dalla Francia, alla Svezia, all’Olanda alla, Gran Bretagna. Piani straordinari di lavoro di utilità pubblica, o diversamente denominati, ma con la stessa sostanza, a fianco di piani di formazione. Si dovrebbe trattare di “mini-job” o “midi –job”, secondo la definizione adottata in Germania, con un impegno di orario di lavoro ridotto e con un salario sociale compreso fra 400 e 800 euro mensili – nel nostro caso, un tipo di occupazione straordinaria e temporale, non destinata a sostituire l’acquisizione di un’occupazione e di un salario regolari, ma mirata a offrire ai giovani una possibilità di integrazione, di sperimentazione , di sostegno economico anche quando vivono in famiglia.
Un piano per il lavoro – bisogna insistere su questo punto – non ha solo un carattere, pure indispensabile, di carattere sociale, ma anche di leva più direttamente e immediatamente disponibile per rilanciare la crescita. Ma è un piano che deve essere finanziato con risorse sufficienti, e questo esige un’iniziativa politica verso l’Europa. La prima, assolutamente razionale, è il rinvio del pareggio del bilancio, insensatamente promesso dal governo Berlusconi a Bruxelles per il 2013. Nessun altro paese dell’eurozona ha assunto quest’impegno. Sarkozy aveva preso l’impegno dell’azzeramento del disavanzo per il 20016, e Hollande, appena eletto, ha dichiarato di rinviarlo ancora di un anno al 2017. Questo consente una disponibilità di bilancio oscillante almeno fra 20 e 30 miliardi di euro da impegnare nel piano del lavoro.
Il secondo punto è il rinvio dell’approvazione del fiscal compact che impone a fianco del pareggio di bilancio la riduzione del debito dal 120 al 60 per cento del PIL in uno scenario che è oggi di recessione e che si annuncia di sostanziale stagnazione per i prossimi anni. Si tratta di misure che debbono essere subordinate a una distinzione essenziale fra spesa corrente e spesa per investimenti: una qualificazione della spesa indispensabile per elevare il potenziale di crescita e, per questa via ridurre, la quota del debito sul PIL – una misura in passato sostenuta dallo stesso Monti come membro della Commissione europea.
Il terzo punto ci riguarda direttamente l’Italia, ed è la messa in atto di una imposta patrimoniale straordinaria sui grandi patrimoni desinata a sostenere l’avanzo primario necessario per pagare gli interessi, il cui ammontare nell’ordine di 80-90 miliardi l’anno espone l’Italia alla speculazione internazionale e a livelli di tassi insostenibili.
Questo non significa rinunciare alla rivendicazione di un sistema efficace di sostegno collettivo tramite l’emissione di eurobond, e a un intervento della Banca centrale per porre un freno alla speculazione sui tassi di interesse. Ma,per quanto ragionevoli, sono misure che la Germania ha ostinatamente rigettato e con ogni probabilità continuerà a ripudiare. Ma anche chi ha un’opinione diversa, chi, probabilmente illudendosi, pensa che la Germania possa rovesciare la sua posizione, deve riconoscere che le tre misure che abbiamo indicato appartengono alla responsabilità del governo italiano e delle forze che lo sostengono.
L’inerzia associata a una cieca subalternità alle politiche europee di austerità senza sbocco e di controriforme sociali non solo comportano un’insopportabile approfondimento della crisi sociale, ma minacciano il funzionamento stesso delle istituzioni democratiche con il passaggio progressivo da una fase post-politica, dominata da tecnocrati privi di legittimazione popolare, verso un regime post-democratico.
(Articolo comparso in "Alternative per il socialismo", giugno 2012