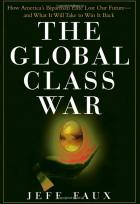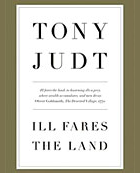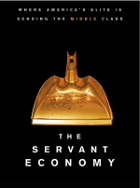Institutes |
Il ritorno della libertà di licenziare
Sottotitolo:
Il nuovo attacco diretto alla deregolazione del licenziamento individuale. Il lavoratore può legittimamente dimettersi in ogni momento senza neanche dire perché. Però, se viene licenziato, può costringere l’imprenditore a convincere il giudice che il licenziamento è giustificato e, qualora il ricorso sia accolto, sarà indennizzato. E’ quel che ho insegnato ai miei studenti per molti lustri. Ma non prima dell’anno accademico 1966-67. E’ del luglio del 1966 infatti una legge che rompeva con tutte le cautele del caso la lunga tradizione giuridica, codificata nel 1942, secondo la quale per estinguere il rapporto di lavoro basta la volontà di una delle parti, col solo obbligo del preavviso; e ciò sebbene il licenziamento sia un provvedimento che, mentre per chi lo attua può essere perfino un capriccio, per chi lo subisce può essere un dramma. Probabilmente, invece, già durante l’anno accademico 2011-12 gli studenti dei corsi di diritto del lavoro dovranno metabolizzare concetti sensibilmente diversi. Infatti, sembra imminente una revisione della legislazione vigente che presumibilmente equiparerà la libertà economica dell’imprenditore alla libertà personale del suo dipendente nella misura in cui il licenziamento riavrà un trattamento più prossimo a quello previsto per le dimissioni e comunque meno penalizzante dell’attuale. Tale riavvicinamento non esige l’abrogazione dell’art. 18. Anzi, ormai è improprio collocarla al centro della riforma; come invece accadde dieci anni fa, quando la norma statutaria si attirò gli strali del governo Berlusconi a causa della sua durezza sanzionatoria, che (come è noto) tocca il punto più alto con la ricostituzione non solo formale del rapporto di lavoro e dunque con l’effettiva reintegrazione del lavoratore sostituibile da una indennità pari a 15 mensilità per scelta del lavoratore ingiustamente licenziato. L’estensione del divieto e l’indeterminatezza della sua formulazione testuale lo trasformano in un vincolo destinato a retro-agire sulla gestione dell’impresa e perciò a collidere con la garanzia costituzionale della libertà d’iniziativa economica. Non che la disposizione legale sia incostituzionale. Posto che, secondo la Costituzione, la libertà d’impresa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”, è pura ideologia sostenere che il licenziamento – soltanto perché intimato per motivi oggettivi – sia in sé socialmente utile. Preso per far quadrare i conti aziendali, esso costituisce l’esito di un calcolo di convenienza che l’imprenditore effettua confrontando l’utilità economica di tenersi il lavoratore e il vantaggio che gli procura il suo licenziamento. Ma, hanno pensato gli autori della legge del 1966, tocca al giudice – e a chi, sennò? – stabilire l’entità del sacrificio che è ragionevole imporre all’impresa. Per questo, i riflettori sono sempre stati puntati sull’applicazione che i giudici fanno della legge limitativa del licenziamento. Per apprezzare in pieno l’impulso dato dalla prassi giurisprudenziale ai propositi revisionisti di cui oggi sono piene le cronache, è sufficiente rifarsi all’indulgenza del ceto imprenditoriale (e dei suoi avvocati di fiducia) verso la disposizione legislativa del 2001 che consente “l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo”. Eppure, anche qui si è in presenza di una definizione legale del giustificato motivo della predeterminazione della durata del contratto di lavoro che, come nel caso del giustificato motivo del licenziamento, lascia al giudice un’ampia discrezionalità valutativa ad esito incerto. Sennonché, l’effetto limitativo di quella norma non può dirsi indebolito dal filtro giudiziario sia perché il fenomeno del precariato è alimentato da una impressionante quantità di contratti variamente strutturati dalla legge del 2003 in alternativa alla figura classica del contratto a termine, sia perché molti sono i fattori che trattengono il precario dal rivolgersi al giudice; molti di più di quanto non possa averne un lavoratore licenziato. Insomma, il contenzioso giudiziario relativo alla liceità dell’apposizione del termine finale del rapporto, quantitativamente inferiore a quello delle controversie in materia di licenziamento, non preoccupa. Ciò significa che anche la pressione per ri-regolare il licenziamento sarebbe meno violenta se non si fossero accumulate decisioni di giudici (dal pretore di provincia su su fino alla Cassazione) che s’industriano – con la saggezza empirica di cui sono capaci e il patrimonio di cognizioni di cui dispongono – di ricercare un accettabile bilanciamento tra la tutela dell’interesse degli occupati alla conservazione del posto di lavoro e quella dell’interesse dell’imprenditore a ridurre i costi aziendali. Perciò, tutto il problema nasce dal fatto che il ceto imprenditoriale si aspettava che la magistratura si limitasse ad accertare la coerenza del nesso di causalità tra la motivazione del licenziamento e la decisione di licenziare, convalidando la valutazione compiuta dall’impresa. Un atteggiamento del genere – figlio di una concezione della libertà d’impresa lontana dalla cultura tecnocratica dominante – non è mai piaciuto ai governi Berlusconi, i quali hanno cominciato presto a manifestare la propria contrarietà: dapprincipio, nel Libro Bianco del 2001 e, in seguito, creando un insieme di incentivi della composizione stragiudiziale delle liti di lavoro che esprime un’incomprimibile diffidenza nei confronti dei giudici. Va in questa direzione una norma contenuta nel pasticcio legislativo denominato “collegato lavoro” approvato dal Parlamento nel 2010, dove si afferma che “in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge contengano clausole generali” – come in materia di licenziamento o di assunzione di lavoratori a termine e in genere di “esercizio dei poteri datoriali” – “il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”. Con questo tono, così professorale e così fuori luogo, si impartisce ai giudici la direttiva ermeneutica di imitare l’iter argomentativo caro ai sofisti :“post hoc ergo propter hoc”. Si può anche ironizzare sul desiderio del legislatore di condizionare il processo di formazione del convincimento del giudice al fine di privilegiare a priori uno degli interessi in gioco. Sta di fatto, però, che la strategia di delegittimazione ed emarginazione del ruolo dei giudici (non solo) del lavoro teorizzata nell’era berlusconiana ha sempre goduto di consensi politici trasversali e sono in parecchi a ritenere che, se si vuole sul serio che il ruolo di questi giudici sia sostanzialmente di stile notarile, bisogna stabilire seccamente che quella del licenziamento per motivi “oggettivi” è una vicenda esente dal loro controllo. Non a caso il governo Monti guarda con simpatia un disegno di legge (che non è del Pd, ma è stato) presentato da un gruppo di parlamentari del Pd (primo firmatario: Pietro Ichino), ove è prefigurato un singolare atto civilmente lecito e, ciononostante, produttivo di danni in qualche misura risarcibili: per l’appunto, il licenziamento per motivi “oggettivi”. Il quale diventa così uno strumento ordinario e normale di gestione dell’impresa fuori controllo. In effetti, anche questo è un modo per celebrare l’apologia della scuola di pensiero che predica “più società, meno Stato”. Uno Stato i cui giudici tendono a considerare il licenziamento un’extrema ratio, coonestandolo solo se si persuadono che è privo di alternative. Umberto Romagnoli
Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight. |