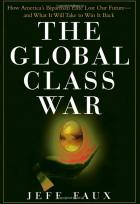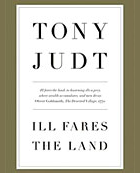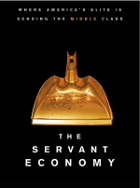Institutes |
La deriva del diritto del lavoro*
Sottotitolo:
Sommario: 1.- Storicità di una norma da abrogare. 2.- La legge non scritta del doppio binario. 3.- L’ininterrotto dominio della gius-privatistica. 4.- Il sindacato come centro privato di co-produzione normativa nel dopo-costituzione. 5.- Niente può fallire come il successo. 1.- Storicità di una norma da abrogare Infatti, la “contrattazione di prossimità” (ossia, aziendale o territorialmente circoscrivibile) può derogare in peius a gran parte della legislazione del lavoro, sancendo così la caduta del predicato dell’inderogabilità (tranne che in melius) delle regole prodotte dalla più blasonata delle fonti costituzionalmente legittimate, e può causare l’evaporazione del principio per cui a lavoro uguale devono corrispondere uguali diritti, economici e non, togliendo così al contratto nazionale la funzione (che un coevo accordo interconfederale intende rilucidare) di “garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale” – certezza che, peraltro, attualmente può soltanto millantare, stante la lacunosità della cornice legale . In un’altra occasione ho scritto che, se un giorno dovesse capitolare, il diritto del lavoro che avevo imparato a conoscere nei miei anni giovanili morirà per sfinimento, stremato da uno stillicidio di modifiche. Più o meno profonde, più o meno sanguinose. Come le banderillas. Che non infliggono ferite letali, ma segnano egualmente l’inizio della fine della fiesta. Bene; quel giorno è arrivato. Ma a vibrare il colpo decisivo non sarà un famoso matador. Nell’arena infatti sono virtualmente scesi a grappoli picadores di cui non è dato sapere neanche il nome. Chissà, forse era scritto che al diritto del lavoro sarebbe toccato morire come era nato: in maniera anonima e senza gloria. Dunque, l’art 8 della legge 148/ 2011 è una norma ustionante. Nell’immediato, la corrispondente disposizione contenuta nel decreto-legge del mese precedente provoca una certa sovra-eccitazione. Anzitutto, fa cadere in ilare delirio il segretario generale della Uil, che esulta: “è il massimo del potere sindacale!”. La Cgil invece proclama uno sciopero di protesta; che però il segretario generale della Cisl, parlando con un giornalista, non esiterà a definire “demenziale” – mentre c’era da chiedersi “se non ora, quando?”, come gli replicò Susanna Camusso. Dal canto suo, l’opposizione politica si comporta come di solito facciamo davanti ad un sisma che non colpisce noi, ma gli altri: promettiamo ai sinistrati di aiutarli appena possibile. Anche per questo, quotidiani e TV non danno alla notizia il rilievo che merita. Né subito né in seguito. Con la sola scusante che maiora premunt. Quelle sono le settimane del concitato ruit hora del governo di centro-destra e le notizie da dare sono altre: lo spread è alle stelle; la gente al passaggio di Giorgio Napolitano gli grida “Ci salvi Lei”; il New York Times titola “L’era di Berlusconi volge al termine” e Le Monde “Silvio sei finito”. Ciò non è sufficiente per negare che le reazioni alla manovra governativa e parlamentare diano la misura esatta dell’estensione raggiunta dall’inquinamento delle falde sotterranee nelle quali il diritto del lavoro aveva messo le radici. L’oscenità legislativa, infatti, crea un clima imbarazzato ed insieme indulgente. Più permissivo che di rigetto. In giro, comunque, l’indignazione è scarsa. Oppure è dissimulata. Perché? Il fatto è che non solo i governanti e la loro maggioranza in Parlamento condividono l’idea che il lavoro rientra in maniera pressoché esclusiva nella sfera degli interessi di chi lo vende e di chi lo compra e che la regolazione dello scambio spetta a soggetti che agiscono in base ad una concezione proprietaria della contrattazione collettiva. Proprietaria anzitutto perché il sindacato si considera un rappresentante sui generis, un po’ mandatario e un po’ tutore, e al lavoratore fa credere d’essere sui generis, anche lui. Un po’ capace e un po’ no. E’ ragionevole presumere che, se il governo Monti non fosse dello stesso parere, avrebbe perlomeno manifestato il proposito di disinfestare l’ordinamento giuridico del lavoro. Si dirà che non si è liberato dell’eccentrico lascito normativo, perché l’Europa non glielo ha chiesto; ma l’obiezione non regge: per motivi d’igiene, una mano di bianco alle pareti dell’appartamento dove hanno traslocato i nuovi inquilini hanno l’abitudine di darla. Anzitutto, nel loro interesse. Dunque, l’omissione governativa non è un trascurabile dettaglio. Anzi, contribuisce a rinsaldare l’opinione che la condivisione del back-groumd dell’art. 8 è molto più ampia di quanto si potesse supporre. E la riprova non tarda ad arrivare. Infatti, è a causa della sua trasversalità che la richiesta di abrogarlo mediante referendum sarà giudicata in contro-tendenza: “inopportuna, scriteriata, populista”, è l’unanime valutazione della polique politicienne. E ciò perché ha il torto di alzare la soglia di attenzione e, incautamente, allertare l’opinione pubblica. Come se fosse una mascalzonata il ripristino della normale dialettica politica della cui autenticità si è ormai perduto il gusto e il ricordo. Come se fosse un imperdonabile errore politico screditare la decisione politica di organizzare il suicidio assistito del diritto del lavoro. Come se le firme raccolte per attivare la consultazione popolare non esercitassero di per sé una forma di pressione sociale sul governo che otterrà la fiducia delle Camere dopo le elezioni del 2013, inducendolo ad inscrivere la cancellazione di una malvagità giuridico-costituzionale nell’agenda delle cose da fare nei “primi cento giorni”. Insomma, l’iniziativa referendaria è un pericolo per la quiete pubblica. A neutralizzarlo, perciò, devono pensarci i mass media. Che, infatti, oscurano totalmente l’informazione, boicottando così la campagna referendaria. In definitiva, il destino del diritto del lavoro sembra interessare soltanto a quanti se ne occupano per motivi professionali. Ma con moderazione. Mentre i più fanno diplomaticamente circolare la voce che il documento legislativo è tanto sgangherato che sarà liquidato o aggiustato nelle sedi competenti, una piccola minoranza si mette seriamente a studiarlo e prende posizione. Si tratta di giuristi-scrittori nessuno dei quali, magari, è disposto a dire di sé, come Gino Giugni, che “non saprà mai se è un giurista prestato alla politica o un politico prestato al diritto”. Ciascuno di essi, però, sa che “il giurista fa politica e i suoi tempi sono quelli della politica”, come diceva Federico Mancini. E’ questa l’etica del mestiere che li ha motivati a scrutinare l’art. 8 alla luce delle prescrizioni costituzionali fino a contare non meno di una mezza dozzina di violazioni. Con rara univocità di vedute. Il che, tenuto conto che i commentatori hanno per lo più l’autorevolezza che i giudici sono inclini a riconoscere ai membri dello star-system accademico dei giuristi-scrittori, permette di prevederne l’influenza sulle decisioni giudiziarie che verranno adottate per risolvere le immancabili controversie applicative. Le voci provenienti dal ceto degli operatori giuridici sono meritevoli di elogio. Non solo per tempestività e ricchezza di analisi. Ma anche per l’ansietà che tradiscono. In effetti, la minaccia di destrutturare un esteso corpus normativo che con grande fatica aveva acquistato una propria organicità e una propria identità è fronteggiata con lo stato d’animo di chi sta vivendo un incubo da Apocalisse e vorrebbe uscirne al più presto. Più intrigante di quanto non si pensi, il non-detto è che l’art. 8 rende palese quel che si celava in una prassi circondata da vasti consensi. Come dire: le conseguenze attese sono apocalittiche anche perché la norma solleva un velo. In greco, Apocalisse non significa soltanto distruzione; significa anche rivelazione di cose nascoste e dunque l’art. 8 non è un mostro generato dal sonno della ragione. E’ vero: non ho la matematica sicurezza che un sospetto del genere abbia sfiorato gli interpreti che ho appena finito di lodare. So tuttavia che sono preparati e disincantati. Per questo mi azzardo a ritenere che lo abbiano avuto, il sospetto, ma lo abbiano rimosso in fretta, dicendosi che è troppo inquietante per poter essere serenamente sopportato. Perché, invece, non farci i conti? Farli significa maturare la consapevolezza che la soppressione dell’art. 8 civilizzerà senz’altro l’habitat giuridico-istituzionale, ma coeteris paribus non comporterà né il blocco né l’inversione delle tendenze di lungo periodo di cui la norma, lo si voglia o no, rappresenta il segmento conclusivo. Il dato da cui partire è che la norma pesca nel profondo perché, valorizzando la dimensione privatistica, patrimoniale e mercatistica degli interessi in gioco, interpella gli operatori giuridici: giudici, avvocati e giuristi-scrittori, ovviamente – ma anche negoziatori sindacali, capi del personale privato e pubblico, consulenti del lavoro. Li interpella direttamente perché costoro non possono dirsi estranei al processo di de-costituzionalizzazione che ha fatto defluire ed allontanato il lavoro, le sue regole e la sua rappresentanza sociale, dalla sfera di un superiore interesse presidiato dallo Stato. Anzi, ne sono stati protagonisti. Ci sono quindi indizi più che sufficienti per costringere a storicizzare la norma, situandola all’interno del più ampio orizzonte di senso ove è rinvenibile la chiave di lettura che permette di riconoscervi l’estremizzazione della logica sulla quale si è costruito l’impianto politico-culturale di un’intera esperienza giuridica. 2.- La legge non scritta del doppio binario. Non tutti sono tenuti a sapere; ciononostante, è bene che il maggior numero possibile di persone e segnatamente i più giovani sappiano che il cambio di regime non innovò il complesso delle preesistente regole del lavoro dipendente. Rimasero quelle contenute nel codice civile del 1942 che, malgrado l’invadenza della coeva ideologia corporativa e le affabulazioni della Carta del lavoro del 1927, custodiva la memoria della loro origine privatistico-liberale certificata dalla giurie probivirali di fine ‘800. Quelle ereditate da una contrattazione collettiva che per un ventennio era stata gestita da sindacati sottomessi ad uno Stato padre-padrone. Quelle che criminalizzavano lo sciopero in tutte le sue forme. L’art. 39 cost. privilegia, tra i numerosissimi profili che possono descrivere il sindacato, quello che ne fa un centro privato di co-produzione normativa – co-produzione perché non può prescindere dalla consensuale collaborazione della controparte – e, al tempo stesso, riconosce al contratto collettivo (nazionale, che era il tipo dominante all’epoca della Costituente) il rango di fonte regolativa vincolante per la generalità dei suoi destinatari. Esso infatti acquista automaticamente un’efficacia para-legislativa in presenza dei presupposti che la legge di attuazione avrebbe dovuto stabilire in conformità all’enunciato costituzionale. Subordinato il riconoscimento giuridico dei sindacati da parte dello Stato all’accertamento della democraticità dei rispettivi statuti, il 4° comma dell’art. 39 concede ai sindacati che si siano volontariamente sottoposti al prescritto test di affidabilità, e lo abbiano superato, il diritto di partecipare ad organismi di rappresentanza unitaria delle categorie professionali. Soltanto così ciascuno di essi è messo de iure nella condizione di concorrere alla formazione di regole del lavoro generalmente vincolanti, anche se de facto vi concorre con un potere contrattuale calcolato “in proporzione dei loro iscritti”. Insomma, i padri costituenti ritenevano che il sindacato “degli iscritti” non fosse la stessa cosa che sindacato “dei lavoratori” e che, in ogni caso, la sindrome universalistica appartenesse più alla storia del sindacato che ad ideologie precostituite. Vittorio Foa riassumerà il loro pensiero testimoniando che il sindacato inteso come un libero soggetto di autotutela munito del potere di rappresentanza degli iscritti in base agli ordinari meccanismi previsti dal diritto civile e, al tempo stesso, come l’incaricato di una funzione di pubblica utilità esercitabile in forma bilaterale “è presente nella stessa costituzione” . D’altra parte, se già in periodo pre-corporativo si percepiva l’irriducibilità al diritto privato del contratto collettivo, è proprio perché gli si attribuiva una natura duale, in bilico tra privato-sociale e pubblico-statuale. Pertanto, come il sindacato si modella sull’icona mitologica del centauro: metà uomo e metà cavallo, così il contratto collettivo è la risultante di un’ibridazione normativa sconosciuta alle categorie giuridiche della tradizione. La principale debolezza del progetto risiedeva non tanto nel suo schematismo burocratizzante quanto piuttosto nella facilità con cui si presta ad una narrazione che finisce per evidenziarne le contaminazioni col fascismo giuridico che aveva cinicamente sfruttato le specificità che contraddistinguono il sindacato e il prodotto di più largo consumo della sua azione, rispettivamente, nel panorama dei fenomeni associativi e nell’ambito delle manifestazioni dell’autonomia privata, per impossessarsene e divorarli. Infatti, giuristi del valore di Gino Giugni e Federico Mancini – gli stessi che, immuni per gap generazionale e diversità di formazione alle seduttive suggestioni che malgrado tutto l’esperienza corporativa seguita a produrre, fonderanno una nuova scuola di pensiero – non disapprovano il legislatore che si astiene dall’attuare il progetto costituzionale. Tutt’al contrario, ne incoraggiano l’inerzia e conferiscono all’inadempienza costituzionale una convincente legittimità storico-culturale. Spiegano, infatti, come ad un movimento sindacale con gli enormi ritardi da colmare che aveva il nostro, quanto ad esperienza di libertà ed autonomia, si dovesse lasciare l’opportunità di costruirsi la sua al di fuori di schemi regolativi prefabbricati dall’esterno e calati dall’alto. Ancora oggi, soltanto per partito preso si può affermare che nelle sue vene ci fossero gli anticorpi per non farsi catturare dalla legislazione intrusiva che le maggioranze parlamentari dell’epoca avrebbero sicuramente partorito. Certamente, l’incipit dell’art. 39 è perentorio: “L’organizzazione sindacale è libera”, e bisogna ammettere che è difficile dire di più con meno parole. Ciononostante, se negli anni ’50 lo Stato avesse legiferato, avrebbe statuito che è lecito soltanto lo sciopero attuato mediante un’astensione simultanea dal lavoro di tutte le maestranze, indetto dalle associazioni giuridicamente riconosciute, a contratto collettivo scaduto e per modificarne le clausole. Pertanto, tra una legislazione che svuota l’art. 40 e una secca inadempienza della promessa dell’erga omnes costituzionale, la scelta appare davvero obbligata: per effetto della conventio ad excludendum che regola la dinamica politica all’epoca della guerra fredda, senza la pressione della conflittualità sociale il modello di società promesso dalla costituzione sarebbe finito nel pozzo delle ambizioni sbagliate. Nel pozzo delle ambizioni sbagliate, però, insieme col breviario legificato del buon scioperante, c’è finita anche la regolazione del pluralismo sindacale nelle ipotesi in cui la concorrenzialità (che è intrinseca al pluralismo) giunga a compromettere il rendimento dei sindacati come centri privati di co-produzione normativa. I padri costituenti sapevano che la compresenza di contratti collettivi sottoscritti da sindacati in concorrenza tra loro e applicabili ai soli iscritti, pur rappresentando un logico corollario di un regime di libertà sindacale incondizionatamente garantita, ha elevati costi sociali e non è utile nemmeno alla controparte: per questo, puntavano sull’unicità dei negoziati e affidavano al principio di maggioranza la soluzione dei conflitti endo-sindacali che si manifestassero nel momento di concluderli. Da un lato, quindi, si preferì fare assegnamento sul pragmatismo dei sindacati, scommettendo sulla loro disponibilità a trattenersi dal farsi sgambetti e ad optare per la cooperazione sufficiente ad assicurare una tendenziale convergenza di comportamenti rivendicativo-contrattuali. Contemporaneamente, si ritenne che il controllo del conflitto sociale avrebbe guadagnato moltissimo sul piano dell’efficienza se, anziché una legge sindacale organica varata dopo infinite turbolenze politico-parlamentari ed esposta a rilievi d’incostituzionalità da parte del giudice delle leggi che prima o poi si sarebbe dovuto istituire, lo Stato avesse agito per vie interne, servendosi con discrezione di soggetti istituzionali politicamente non responsabili, come i magistrati, i questori e i prefetti, ma culturalmente più legati al passato e dunque meno ostili alla legificazione cingolata emanata in età fascista. Infatti, il giudizio di disvalore che essa si era guadagnato in significativi settori della società civile e politica stentava a penetrare negli apparati statali; qui, anzi, erano in molti a ritenere che potesse bastare un energico, ma intelligente maquillage. Lo Stato, insomma, sceglie una linea di politica del diritto morbida, flessibile, praticabile senza provocare contrasti frontali. Ai miei studenti ne parlavo come della legge non scritta del doppio binario: non-ingerenza e non-indifferenza. E’ la legge che ha trovato applicazione per tutto il tempo occorrente per bonificare il terreno nel quale era germogliata la normativa fascista. Pertanto, il sindacato del dopo-costituzione è ancora un’istituzione della società civile la cui adolescenza, che sembra destinata a non finire mai, continua ad essere agitata. In ogni caso, l’informalità e la precarietà della cornice normativa impediscono al sindacato di essere come piacerebbe di più a lui ed ai suoi rappresentati; al tempo stesso, però, impediscono allo Stato e alle imprese di interloquire con un sindacato come lo vorrebbero loro. 3.- L’ininterrotto dominio della gius-privatistica. Come accennavo poc’anzi, tra le numerose ragioni della scomparsa dell’art. 39 (e dell’art. 40) dal radar del Parlamento non è secondaria quella che ha a che fare col ruolo dei giuristi che avevano marcato la stagione dell’ascesa del diritto sindacale e del lavoro nel dopo-guerra. In proposito, spicca il nome di Gino Giugni. Nel giro di pochi anni, la sua Introduzione allo studio della autonomia collettiva – che è del 1960 – diventa, come tutta la sua fitta saggistica, una lettura formativa obbligatoria per intere generazioni di giuristi del lavoro e larghi strati della popolazione forense. L’esito non era affatto scontato. Per questo, non è ozioso chiedersi come mai la sua egemonia culturale abbia potuto stabilizzarsi senza costringerlo a sostenere un duello in campo aperto: “quasi senza lotta” – confesserà lo stesso Giugni, più stupefatto (e un po’ deluso) che soddisfatto . Di sicuro, non si ebbero scontri dialettici paragonabili, per livello di pathos e dovizia di argomenti, a quello che nella prima metà degli anni ’50 vide la gius-pubblicistica, rappresentata da Costantino Mortati “nello spirito della costituzione”, lanciarsi all’assalto della materia sindacale e del lavoro per impadronirsene e la gius-privatistica, rappresentata da Francesco Santoro Passarelli, respingerlo con dura determinazione “nello spirito della libertà dei privati”, riaffermando il dominio assoluto che aveva instaurato dalle origini. Il che, tradotto nel linguaggio di un giovane dell’epoca ai primi passi della carriera universitaria, voleva dire che ”le cattedre di diritto del lavoro sarebbero state aggiudicate in quasi totalità all’area privatistica” . Come mai, allora, è potuto succedere che i vincitori degli anni ’50 abbiano ceduto il copy-right dell’identità disciplinare del diritto del lavoro ad un outsider eretico come Giugni? Enfatizzano, tutti, la superiorità della contrattazione collettiva come strumento regolativo in alternativa alla legge: ma l’entità che idealizzano ha una valenza esclusivamente extra-legislativa e, se la glorificano, è soprattutto perché indossa un abito che non può non andarle stretto, visto che il diritto comune dei privati non sa nemmeno cosa sia – senza per ciò solo suscitare ripensamenti: “nulla sarebbe più inutile che ripercorrere per il verso contrario l’autonomia collettiva di Santoro Passarelli”, è la concisa conclusione cui perviene Giugni nel 1996. Si dicono convinti, tutti, che il diritto del lavoro non è scritto nel libro V del codice civile, ma nemmeno nella costituzione; e difatti nessuno di loro prova un serio imbarazzo a considerare bene economico tutto ciò che è fonte di arricchimento: a cominciare dal lavoro che, secondo i sacri testi, “non è una merce”. Su queste sponde non ci sono arrivati né per caso né da soli. Vi sono stati traghettati dalla tradizione civilistica. Come dire che il tramonto della gius-privatistica non significa che il suo messaggio venga lasciato cadere. Ha dei continuatori: per questo, Mario Rusciano può (dottamente) parlare di prospettive “sincronicamente complementari” . Il dissenso, infatti, attiene alla metodologia di ricerca impiegata e quella di Giugni rompe col legalismo di una tradizione stato-centrica. Ma, stando così le cose, ai dissenzienti-perdenti non resta che consumarsi in un comprensibile, ma banalissimo risentimento. Quello di essersi fatti sorpassare dal collega che, presagendo il futuro, aveva intuito che la storia avrebbe premiato chi si fosse per primo messo a riflettere in maniera sistematica sul provvisorio. Dopotutto, dal momento che la legge sindacale organica non sarebbe mai arrivata, tanto valeva considerare permanente il transitorio e cercare di capire cosa ci si poteva costruire sopra. Anzi, come ha scritto Giovanni Cazzetta, “nel silenzio della legge, sarà soprattutto a contatto del diritto effettivamente prodotto giorno dopo giorno dai privati che la disciplina troverà quel cemento scientifico che ricercava da tempo” . 4. – Il sindacato come centro privato di co-produzione normativa nel dopo-costituzione. Bisogna ammettere che si è giocato un gioco di cui nessuno era in grado di prevedere tutti gli sviluppi. Per un lungo tratto, però, le cose hanno funzionato passabilmente. Sia pure non senza espedienti e contraddizioni. E valga il vero, come arringavano gli avvocati d’una volta. Non è privo di spregiudicatezza il sindacato che, pur sviluppandosi in aperta polemica con la legislazione corporativa, tifa per la vittoria nelle aule giudiziarie dell’opinione favorevole a blindare i contratti collettivi da lui stipulati con gli automatismi previsti dalla legge del 1926 legata al nome di Alfredo Rocco. Infatti, è con l’apporto di esperti di riciclaggio delle leggi in contesti mutati che la normativa di cui il sindacato del dopo-costituzione è un co-produttore si è procurato il requisito dell’inderogabilità che era coessenziale ai contratti collettivi corporativi. Ancora: pur rifiutando di servirsi di stampelle legali per allargare la sfera d’efficacia soggettiva dei contratti collettivi nelle forme costituzionalmente stabilite, il sindacato ha seguitato a pensare che il contratto nazionale orfano dell’erga omnes fosse paragonabile ad un grande serbatoio idrico sprovvisto dell’impianto capace di trasformare l’energia potenziale dell’invaso in energia cinetica e di trasportare l’elettricità in tutte le abitazioni. Per questo, non ha fatto le barricate quando il Parlamento decise in via transitoria di garantire l’erogazione del servizio aggirando l’art. 39 – eravamo nel 1959 – ed ha sempre valutato positivamente il formarsi del massiccio orientamento giurisprudenziale che – con buona pace del diritto comune secondo il quale il contratto ha forza di legge solamente tra le parti, ma fornendo un esempio di scuola della creatività degli interpreti – estende ai senza-tessera sindacale gli standard protettivi valevoli per gli altri. Ad ogni modo, la visibilità politicamente più significativa dell’intenzione di non scaricare il prezzo del vuoto creato dall’inattuazione dell’art. 39 sulla moltitudine dei non-sindacalizzati, ossia della stragrande maggioranza dei lavoratori, è stata raggiunta con la decisione dei sindacati di far cadere l’accento su ciò che li unisce evitando quanto più possibile di acutizzare ciò che li separa. Per questo, come non si stanca di ripetere Gian Primo Cella ed ha perfettamente ragione,“l’unità d’azione è stata una vera e propria alternativa funzionale alla mancata applicazione dell’art. 39” . Infatti, il dinamismo evolutivo del diritto sindacale e del lavoro è stato governato da una coalizione con le caratteristiche di un club, l’ammissione al quale era una faccenda tra e di privati disposti a dispensarsi reciprocamente certificati di garanzia del pedigree esibito. E’ il club delle confederazioni maggiormente rappresentative. Lo starci dentro insieme – c’è stato un momento in cui il club immaginario pareva in procinto di trasformarsi stabilmente in una “federazione unitaria” – aveva una valenza para-costituzionale, perché permetteva al sistema contrattuale di posizionarsi fuori della costituzione senza per ciò solo antagonizzare il rapporto con essa. L’insieme di questi rimedi, però, non poteva cicatrizzare la ferita subita dalla costituzione. Infatti, poiché l’unità d’azione si basa su di un tacito patto il consenso al quale è revocabile in ogni momento per calcoli d’opportunità, ogni tanto tra le maggiori confederazioni scoppiano liti e, come in famiglia, volano i piatti. Ma, fino ad una diecina di anni fa, le crisi non colpiscono il cuore del sistema. Infatti, i carissimi nemici non danno segni di voler abbandonare il gioco che hanno cominciato a giocare in qualità di enti esponenziali della società civile dopo la scoperta che l’antica massima ubi societas ibi ius può non significare soltanto che la società non può fare a meno del diritto: significa anche che la società produce diritto in senso proprio, un ordinamento cioè che – secondo la teorizzazione, in parte giustificazionista e in parte predittiva, di Giugni – possiede una propria originalità normativa ai cui margini si arresta anche lo Stato, con le sue leggi e i suoi giudici. 5.- Niente può fallire come il successo. Niente può fallire come il successo, è il parere di uno che se ne intende. Nondimeno, sarebbe una sciocchezza aspettarsi che i sindacati si comportassero come il figliol prodigo che torna dal padre per confessargli i danni che ha causato alle stesse idee di progresso per seguire le quali se ne era andato di casa. Oltretutto, non ce n’è neanche bisogno. La Cgil non ha nulla da rimproverarsi per non essersi fidata di un Parlamento che nella lunga stagione dei governi centristi demonizzava tutto ciò che aveva odore di sinistra di classe e, da parte sua, la neo-nata Cisl aveva tutto l’interesse a dissuadere il suo partito politico di riferimento dall’insistere per colmare il vuoto regolativo tramite una legge che, trasferendo il principio di maggioranza nella dinamica delle relazioni industriali, rischiava di strozzarla nella culla. In ogni caso, è assolutamente impossibile ripartire daccapo. E ciò, come ha scritto Stefano Rodotà, non solo perché “non c’è l’ora X in cui può essere presentata all’incasso la cambiale” del rinvio dell’attuazione costituzionale, ma anche perché “quello che intercorre tra il giorno dell’approvazione della costituzione ed il giorno della sua attuazione non è un periodo che possa essere ignorato, quasi fosse una parentesi chiusa la quale si torna alla purezza delle origini: heri dicebamus”. Come dire: prima di decidere sul da farsi, è indispensabile stabilire cosa sia successo medio tempore. Può darsi infatti che in materia sindacale e del lavoro sia successo quel che una ricognizione storico-critica ha accertato in altre materie di rilevanza costituzionale: tra “la posizione di chi subì il rinvio come una realistica necessità” e “quella di chi vedeva in esso lo strumento che consentiva di accantonare definitivamente” la questione ha nettamente prevalso la seconda . Nel caso nostro, anzi, è accaduto di peggio: l’ampio ricorso tra gli anni ’70 e gli anni ’80 alla c.d. legislazione devolutiva postulava addirittura la finzione che la questione si fosse in qualche modo risolta. Ciononostante, colpisce la tendenziale mancanza di vigilanza su quanto stava capitando. Non ci siamo nemmeno accorti di quando sia cominciato questo calo di tensione. Tuttavia, è plausibile supporre che lo slittamento di ragioni e significati della disattivazione costituzionale non sia avvenuto di colpo e sia invece graduale; graduale quanto il superamento della legge non scritta del doppio binario sia per effetto dell’esaurirsi delle sue potenzialità che in seguito ai mutamenti degli scenari, politici e normativi. Si può convenire, quindi, che esso è cominciato dopo che lo statuto dei lavoratori si è intrecciato col duttile atteggiamento dello Stato verso le tematiche sindacali e del lavoro, da un lato, sostituendo alla non-indifferenza un positivo interessamento e, dall’altro, traducendo la non-ingerenza in una direttiva di sostegno all’auto-composizione della conflittualità sociale senza la pretesa di regolarne soggetti e mezzi; Tutto ciò, e molto altro ancora, è successo nell’arco di svariati lustri. Senza suscitare ripensamenti e anzi, casomai, rafforzando la percezione dell’irreversibilità dello scostamento dal progetto costituzionale. L’immobilismo è generale, ma quello del sindacato è monumentale. Esemplare è la sua insensibilità ai dati emersi dal massiccio sondaggio d’opinione di cui dicevo poco fa. Infatti, si è comportato come se i quesiti referendari fossero un fastidio e i responsi popolari praticamente ininfluenti. Come dire che non è stato sollecitato ad una reazione che non fosse di miopia rancorosa. Viceversa, l’elettorato non si sarebbe pronunciato per l’abrogazione della norma dello statuto che obbligava gli imprenditori (a richiesta dei dipendenti) a riscuotere le quote sindacali tramite trattenute sulle buste-paga, se non si fosse persuaso che il sindacato sia un’associazione eguale a tutte le altre e dunque se non avesse visto un trattamento di riguardo ormai destituito di buone giustificazioni in ogni forma di agevolazione del suo auto-finanziamento. Ancora più deprimente è stata la sotto-valutazione della risposta sillabata dall’elettorato al secondo quesito referendario; e ciò perché il responso popolare lesionava gravemente la trama statutaria, producendovi una crepa che l’attraversa tuttora come una faglia. In effetti, come avrò agio di precisare poco più avanti, la riscrittura dell’art. 19 st. aveva il significato e la portata di un colpo d’accetta alla confederalità come dimensione caratteristica del movimento sindacale italiano o, perlomeno, di una premonizione degli alleggerimenti del suo tasso di politicità cui stiamo assistendo. Più teneri non si può certo essere col ceto professionale degli operatori giuridici. Era stato lestissimo a sponsorizzare l’astensionismo legislativo accreditandolo come una felix culpa in quanto interpretabile qualcosa di diverso da un volgare inadempimento costituzionale. In seguito, però, di lui può apprezzarsi soltanto o soprattutto la rapidità con cui ne ha metabolizzato la conversione in un bene o valore in sé, indipendentemente dal suo porsi in rotta di collisione col progetto che aveva affaticato i padri costituenti alla ricerca di un equilibrio tra la dimensione privato-sociale e la dimensione pubblico-statuale del lavoro, del sindacato e della contrattazione collettiva. In effetti, l’appiattimento sull’esistente è totale. Non so se soltanto per pigrizia mentale; in ogni caso, è da escludere che sia l’esito ragionato di una convinta e soddisfatta adesione al bilancio del pluralismo giuridico che aveva nell’ordinamento sindacale iure proprio il paradigma della profezia che si auto-adempie. Il bilancio è pressoché fallimentare, come è desumibile dall’impressionante quantità di prove dell’inadeguatezza del sindacato come centro privato di co-produzione normativa: basterebbe pensare alla sua deplorevole irresolutezza di fronte al nodo dei rapporti con la base ed a come essa si rispecchia nell’inconcludenza della normativa pattizia sulle forme di rappresentanza endo-aziendale. Fatto sta che intere generazioni di comuni mortali sono stati colpevolmente lasciati nella condizione di non sapere chi rappresenta chi né come possano essere regolati i dissensi insorti in corso di trattative tra rappresentanti di sigle sindacali evitando che diano luogo a traumatizzanti crisi di sistema; chi è legittimato a stipulare contratti e con quale efficacia; quali siano i criteri che delimitano l’ampiezza del potere dispositivo né quali sanzioni possano essere inflitte in caso di violazione. Cecità o sordità, insomma, rappresentano la maniera con cui gli operatori giuridici si sono fin qui risparmiati scomodi interrogativi sulla crescente opacità del pensiero forte di una politica del diritto che aveva raggiunto il suo punto più alto con la legge 300 del 1970 e sul suo crescente scollamento con la realtà (non solo) normativa. Ma, in quanto espressione di un pregiudizio sfavorevole al progetto costituzionale, la matrice della mancata reattività è ideologica. Infatti, un conto è pronunciarsi a favore dell’idea che senza la libertà dei privati non si ottengono conquiste sociali, altro è piegarla a sostegno della tendenza a raccontare le virtù del privato e le meraviglie della sua primazia. E ciò perché, in una democrazia costituzionale, è inammissibile la vocazione all’autoreferenzialità di tutti i poteri, qualunque natura essi abbiano. Quindi, neanche il sindacato può sottrarsi a verifiche riguardanti il fondamento della sua legittimazione a partecipare da protagonista a processi di produzione di norme valevoli nei confronti di moltitudini di cittadini che non gli hanno conferito alcun mandato rappresentativo. Anzi, più si rivendica l’autonomia del potere contrattuale collettivo più se ne aumenta la responsabilità nei confronti della collettività per conto della quale è esercitato. “Il disegno di legge che il mio ministero sta elaborando”, aveva annunciato Giacomo Brodolini, “si propone di fare del luogo di lavoro la sede della partecipazione democratica alla vita associativa sindacale e alla formazione di tramiti democratici di comunicazione tra il sindacato e la base dei lavoratori”. Non che l’additivo della maggiore rappresentatività sindacale sia di per sé privo di effettività; al contrario: proprio perché deve farne il pieno in ogni istante, è a rischio di volatilizzarsi. Lo ha riconosciuto anche la Consulta che più ci aveva creduto. Infatti, pur avendo pensato per una ventina d’anni tutto il bene possibile del club delle grandi confederazioni come luogo (sono sue parole) della “sintesi tra istanze rivendicative di tipo micro-economico e di tipo macro-economico”, nel 1990 redarguisce l’establishment: privilegiare l’autoregolazione privato-sociale sta bene; però, la legittimazione dei sindacati deve essere accertata in base a “regole ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato” . Sotto-traccia, ma egualmente riconoscibile, è l’irata volontà dell’Alta Corte di trattare i sindacati come una volta i padri di famiglia trattavano i figli indisciplinati: gli si toglievano le chiavi di casa perché rientravano tardi la sera. Più ruvido e spicciativo, comunque, è stato il legislatore popolare che nel 1995 ha riscritto l’art. 19 st. Da allora, il diritto di cittadinanza in azienda è riconosciuto sempre e soltanto al sindacato firmatario del contratto collettivo applicato nell’azienda. Come dire: la soglia della rappresentatività del sindacato autorizzato a parcheggiarsi nella normativa promozionale si abbassa al livello aziendale e la sua effettività è documentata dalla sottoscrizione del contratto collettivo che si applica nell’ azienda – irrilevante essendo che sia l’unico contratto che il sindacato ha potuto o voluto stipulare e il contratto sia applicato in una sola azienda. Nella sua versione originaria, l’art. 19 era figlio dell’idea che, in Italia, quella sindacale sia una storia di confederazioni “doc” di cui il legislatore statutario neanche si sognava che si potesse mettere in discussione la rappresentatività. Lui, comunque, giudicò superfluo subordinarne il riconoscimento a verifiche condotte con criteri oggettivi e trasparenti. Esagerava, però: sancire che la maggiore rappresentatività delle confederazioni s’irradiasse con la velocità della luce a tutte le sue federazioni nazionali e provinciali anche là dove contano come il due di coppe a briscola vuol dire formulare una presunzione fondata su un’altra presunzione e in base ad essa accordare i vantaggi e i privilegi previsti dal titolo III dello statuto. Si sarebbe dovuto nutrire qualche dubbio sull’ammissibilità di un quesito referendario che si abbatte con l’effetto di un defoliante sulla normativa cui appartiene il frammento normativo da impallinare. Non diversamente si sarebbe dovuto formare un più compatto schieramento circa il giudizio sul correttivo introdotto dalla consultazione popolare e censurarne la sua eccessiva, sproporzionata efficacia: un po’ come curare il mal di testa con la decapitazione. Una prima volta, perché il sostegno legale olim concesso ai sindacati confederali spetta a qualunque associazione sindacale in qualità di agente contrattuale che gestisce interessi concreti e specifici, a misura del campo di applicazione del contratto collettivo, ossia a misura della singola azienda. Una seconda volta, perché la selezione del sindacato con visto d’ingresso nella zona del privilegio legale diventa una vicenda su cui interferisce necessariamente anche la controparte nella misura in cui è libera di scegliere i suoi interlocutori contrattuali. Nell’immediato, la criticità della dissociazione tra legislatore popolare e legislatore statutario è colta solo parzialmente. Il che, del resto, non sorprende, perché l’essenza dei testi legislativi quasi mai si coglie nelle parole di cui si compongono, anche se non potrebbero essere più esplicite. La vera essenza sta oltre la dizione testuale: sta nell’accoglienza ambientale che riceveranno. Perciò, non è che un segno dei tempi il prevalere per un certo periodo di una lettura riduttiva della plateale divaricazione degli orientamenti legislativi. Il 22 gennaio 2009 un accordo-quadro fissa le linee-guida per cambiare in profondità il dna del sistema contrattuale edificato per stratificazioni successive nel dopo-costituzione, ma senza l’adesione della Cgil, ossia del più rappresentativo dei membri del governo di coalizione sindacale che per sessant’anni ha guidato l’evoluzione normativa del lavoro. Nel 2010, l’art. 19 è utilizzato per estromettere dal gruppo Fiat un sindacato di cui nessuno si sogna di contestare l’effettiva rappresentatività, solamente perché non ha firmato per dissensi di merito il contratto applicato in quell’azienda e, nel 2012, il medesimo sindacato che non aveva sottoscritto il contratto nazionale scaduto sarà escluso anche dalle trattative per il suo rinnovo, benché un accordo interconfederale siglato il 28 giugno 2011 per ristabilire un clima di cooperazione consensuale nel mondo sindacale sia sostanzialmente modellato sull’accordo-quadro del 2009. Come dire: lo slancio di ravvedimento operoso non ha avuto seguito alcuno. ___________________________________________________________
Umberto Romagnoli
Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight. |