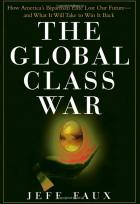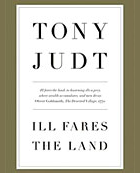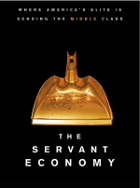Institutes |
La legge sulle due cittadinanze
Sottotitolo:
Il lavoro è un fattore importante della cittadinanza e la contrattazione ne costituisce una leva essenziale; ma è un'eresia giuridica supporre che il contratto possa sacrificare elementi costitutivi della cittadinanza. Se ha un passato di cui gloriarsi, è possibile e comprensibile che il sindacato sia accompagnato da una concezione agiografica che fa di lui il più democratico tra tutti gli enti esponenziali della società civile. In bilico tra apologia e ideologia, la concezione è giustificata dal ruolo storicamente svolto dall’istituzione nazional-popolare che, nell’Occidente capitalistico, ha traghettato gli uomini col colletto blu e le mani callose dallo status di sudditi di uno Stato elitario allo status di cittadini di uno Stato democratico pluriclasse. Da sola, tuttavia, non è in grado di cancellare un dato di realtà: il sindacato è anche e anzi, più spesso di quanto non si pensi, soprattutto un’autorità nei confronti degli stessi lavoratori che intende proteggere. Esercita infatti il potere di co-determinare le condizioni di lavoro stipulando contratti collettivi applicabili non solo agli iscritti. E’ quindi scontato che il livello di democratizzazione delle forme di esercizio del potere contrattuale collettivo dipenda dall’intensità (intesa come continuità e incisività) della partecipazione al processo decisionale assicurato ai destinatari della normativa i quali, in larghissima maggioranza, sono estranei alla vita associativa del sindacato. Orbene, a chi ne denuncia l’insufficienza, e magari si duole che la sinistra non lo consideri un problema, non è inutile rammentare che la questione non scaldò nemmeno i padri costituenti cui nessuno può rimproverare di non avere dato risposte convincenti alla domanda di democrazia che percorreva il paese. Eppure, si rendevano conto che la generalizzazione dell’efficacia vincolante del contratto collettivo finisce per accentuare l’aspetto autoritario dell’agente che lo sottoscrive. Anche loro pensavano che l’autorità, ovunque si manifesti, non può avere di per sé la virtù della democraticità; casomai, ne è intrinsecamente sprovvista. Tant’è che non aderirono all’idea che il sindacato sia naturaliter democratico. Infatti, valutarono l’opportunità di connettere la legittimazione del sindacato a contrattare con efficacia erga omnes all’affidabilità democratica del medesimo, ricavandone i concordanti indizi dal confronto del suo ordinamento interno con un presunto ideal-tipo di associazione. Questo è il test che imposero di superare qualora, per svolgere pienamente il proprio ruolo, fosse interessato a trasformarsi addirittura in un legislatore privato. Ne fecero la condizione necessaria – a differenza che per qualunque altra associazione, inclusi i partiti politici che ne sono esonerati. Ma la condizione è necessaria ed insieme sufficiente. Può darsi che sia una manifestazione di irenismo costituzionale. Però, è scusabile. Era la prima volta nella storia dell’Italia unita che si cercava di definire l’assetto dei rapporti tra Stato e sindacati in un regime democratico. L’art. 39 cost. privilegia, tra i numerosissimi profili che possono descrivere il sindacato, quello che ne fa un centro privato di co-produzione normativa – co-produzione perché non si fanno norme senza la consensuale collaborazione della controparte – e, al tempo stesso, riconosce al contratto collettivo (nazionale, che all’epoca della Costituente dominava) il rango di fonte regolativa vincolante per la generalità dei suoi destinatari. Esso infatti acquista un’efficacia para-legislativa in presenza dei presupposti che la legge di attuazione avrebbe dovuto stabilire in conformità all’enunciato costituzionale. E’ ancora corretto parlare di contratto? Non risulta che i padri costituenti se lo siano chiesto. Nondimeno, sapevano che ne ha soltanto la faccia e, nella sostanza, è un ibridismo che mima la legge. Si può ancora parlare di contratto concluso da un rappresentante? Sì, risposero, ma a condizione di non nascondersi che è un rappresentante sui generis: somiglia più ad un tutore che ad un mandatario. In conseguenza, anche il rappresentato è sui generis: è un soggetto a sovranità limitata, a metà strada tra il capace e l’incapace. D’altra parte, se (come è certo) bipolarità del sindacato e natura duale della contrattazione collettiva si traducono in un’anomalia irriducibile alle categorie del pensiero giuridico stato-centrico che da noi ha dato origine ad una persistente situazione di singolare a-legalità costituzionale, bisogna riconoscere che essa è stata metabolizzata anche dagli autori dello statuto dei lavoratori. L’art. 19 dello statuto premiava la maggiore rappresentatività dei sindacati perché l’assimilava alla capacità di organizzare il contropotere collettivo nei luoghi di lavoro, ma non la considerava un’espressione del consenso effettivo degli occupati nell’azienda. E’ per questo, difatti, che nel 1990 la Consulta si pronuncia per la ri-legittimazione del concetto – un concetto che appartiene più alla storia che all’ortodossia costituzionale – in base a “regole ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato” e, nel 1995, sarà celebrato un referendum che ha riscritto l’art. 19 declinando la rappresentatività sindacale in chiave aziendalistica. Insomma, la maggiore rappresentatività era un additivo legale acquistabile a livelli diversi dall’azienda e tra lavoratori diversi da quelli ivi occupati; difatti, si misura al livello più alto possibile di centralizzazione burocratica, quello confederale. Inoltre, è indubitabilmente vero che spetta agli addetti all’unità produttiva prendere l’iniziativa di costituirvi la rappresentanza sindacale, ma è altrettanto vero che – una volta costituita – essa non è tenuta ad alcuna verifica di mandato. Infatti, pur prevedendo istituti di democrazia diretta come l’assemblea e il referendum, lo statuto non impone alle rappresentanze di farne uso per rispondere ai rappresentati. Ciononostante, lo statuto non si limitò ad aprire, come si usava dire, i cancelli della fabbrica al sindacato. E ciò perché lo statuto era ed è una legge sulle due cittadinanze. Quella collettiva e quella individuale. Del gruppo organizzato e del singolo in quanto tale. Lo statuto infatti si propone di sanare la contraddizione per cui dei cittadini attivi nel governo della polis tornano allo stato di sudditi di fronte al governo del proprio lavoro. Benché sia inconsueta nel lessico dei giuristi del lavoro, la definizione ha il pregio di richiamare l’attenzione sulle direttrici dell’esperienza applicativa dello statuto e di incitare per implicito ad interrogarsi sul funzionamento della cabina di regia che presiede all’evoluzione del diritto vivente. Non s’impiegherà troppo tempo per capire che l’ambito delle due cittadinanze ha avuto uno sviluppo diseguale. E’ come se l’esigenza di potenziare il ruolo istituzionale del sindacato-organizzazione che rappresenta l’intero, il totale, il generale avesse fatto aggio sull’aspettativa di rafforzare il ruolo dei rappresentati uti singuli. Il che non sorprende, perché di fronte alla dimensione individuale il sindacato si è sempre trovato in imbarazzo ed ha dovuto sacrificarla per affermare il valore della solidarietà di cui si considera un veicolo privilegiato. L’intera storia sindacale è attraversata da un conflitto latente per realizzare il primato del collettivo sull’individuale; un conflitto che ha lasciato abbondanti tracce nel diritto positivo. Risiede qui la ragione meno controvertibile del fatto che, al di là delle intenzioni, l’applicazione dello statuto è stata sbilanciata da un’autoreferenzialità del collettivo organizzato che ha avuto numerose e non sempre edificanti manifestazioni. Paradigmatica, ed anche la più redditizia, è l’annessione al territorio in cui si applica lo statuto del vasto arcipelago delle pubbliche amministrazioni, benché il legislatore non l’avesse ordinata e, forse, nemmeno auspicata, come testimoniava la formulazione oracolare dell’art. 37. Viceversa, non è soltanto per il sostegno dato alla presenza del sindacato nei luoghi di lavoro che lo statuto segnò un nuovo inizio. “Il diritto di essere informato, consultato, abilitato ad esprimersi nella formazione delle decisioni che riguardano il suo lavoro” è per l’appunto riconducibile alla nuova generazione dei diritti la cui trama avvolge la trentiniana Città del lavoro. Essi sfidano l’impresa a dismettere l’autorità-autoritaria per sostituirla con un’autorità basata, se non sul consenso dei governati, sulla rilegittimazione di se medesima mediante l’adeguamento dei suoi principi d’azione agli interessi extra-contrattuali ed extra-patrimoniali né negoziabili né monetizzabili di cui è portatore il cittadino che lavora. Tuttavia, la loro polivalenza è immanente e la loro multidirezionalità strutturale. Come dire che, con questi predicati, implicano una sfida rivolta simultaneamente anche al sindacato, tenuto a non ostacolarne l’esigibilità nei confronti di se medesimo. Pertanto, la verità è che abbiamo dimenticato gli inizi: “il disegno di legge che il mio ministero sta elaborando”, aveva annunciato Giacomo Brodolini, “si propone di fare del luogo di lavoro la sede della partecipazione democratica alla vita associativa sindacale e della formazione di canali democratici tra il sindacato e la base”. Non insisterò sullo scarto rilevabile tra il proposito dichiarato e la strumentazione effettivamente predisposta, perché lo ha già fatto Massimo D’Antona in un saggio del 1990: “il tit. III dello statuto è una legge sulla cittadinanza del sindacato in azienda che si preoccupa delle garanzie dei rappresentanti di fronte al potere dell’impresa, ma non definisce la posizione dei rappresentati nei confronti dei medesimi”. Adesso, per spiegare cosa sia successo e perché, mi preme piuttosto riprendere una delle “riflessioni su una vita” che Vittorio Foa ci ha regalato e attende soltanto di essere interpretata. “Per molto tempo”, si legge in una pagina di Il Cavallo e la Torre, “abbiamo visto nell’operaio solo un operaio da difendere nel suo rapporto col lavoro e da rappresentare nei suoi soli interessi materiali, e non abbiamo visto gli altri versanti della sua vita”. Come dire: il sindacato ha seguitato ad attribuire al lavoro egemone della società industriale la proprietà di modellare su di sé la nozione di status ricavabile da un ordinamento costituzionale che aveva spostato il centro gravitazionale della figura del cittadino-lavoratore. Il referente sociale non era più l’uomo educato con una coscienza del fine mai vista nella storia agli stili di vita indotti da un modo di produrre che era diventato anche un modo di pensare. Oggi, l’antropologia giuridica appare ridisegnata, perché il sistema giuridico-costituzionale fa affiorare l’immagine dell’individuo con le sue istanze di auto-determinazione di fronte ad ogni potere, per quanto protettivo e benevolo. Forse, è per questo che “ci siamo stupiti quando non ha dato più ascolto ai nostri discorsi”. Foa ragiona da ex dirigente sindacale, ma un giurista del lavoro potrebbe testimoniare che anche la cultura giuridica ha tardato ad accorgersi, nonostante il profondo mutamento dello scenario politico-costituzionale, che la figura del cittadino-lavoratore con l’accento più sul lavoratore che sul cittadino stava tramontando. Infatti, con la complicità involontaria della cultura giuridica del lavoro, il sindacato del dopo-statuto non ha percepito che il riposizionamento del lavoro nelle zone alpine del diritto costituzionale spezza una tradizione di pensiero formatasi “nella prima modernità” allorché, come scrive Ulrich Beck, “dominava la figura del cittadino-lavoratore con l’accento non tanto sul cittadino quanto sul lavoratore. Tutto era legato al posto di lavoro retribuito. Il lavoro salariato costituiva la cruna dell’ago attraverso la quale tutti dovevano passare per poter essere presenti nella società come cittadini a pieno titolo. La condizione di cittadino derivava da quella di lavoratore”. Non che il lavoro non sia più il passaporto per la cittadinanza, tutt’altro; ma è un’eresia giuridica pensare che lo stato occupazionale acquisibile per contratto non possa non sacrificare lo status di cittadinanza. La sua sconfitta è cominciata proprio con lo statuto che, ispirandosi alla costituzione là dove nega che la correlazione biunivoca tra lavoro e cittadinanza possa continuare ad avere la caratteristica instabilità di una barca con sopra un elefante, ha rovesciato la tendenza che faceva dello stato occupazionale il prius e dello status di cittadinanza il posterius. Adesso, l’homme situé – come direbbe Alain Supiot – non può più sovrastare il citoyen e rubargli spazio. Quanto fin qui detto presuppone che l’impatto dello statuto non si esaurisce nel divieto rivolto all’imprenditore di espropriare nei luoghi di lavoro dei diritti civili e politici derivanti dallo status di cittadinanza. Presuppone invece che si accolga un’interpretazione evolutiva ed estensiva del divieto statutario al punto di considerarlo la punta di un iceberg di inusitata grandezza. Esso infatti non comporta soltanto la revisione dei criteri di razionalità e di efficienza produttiva: il che certamente non è poco ed è per questo che ha polarizzato l’interesse tanto degli operatori giuridici quanto degli operatori sindacali ed ha ustionato il management. E’ anche l’input normativo indispensabile per andare oltre la concezione della disciplina del rapporto di lavoro come regolazione d’impianto privato-contrattuale di un rapporto di mercato. Per questo, la fortunata formula del “sindacato dei diritti” che sintetizza con la sobrietà di uno slogan il senso del lascito culturale di Bruno Trentin ha messo il sindacato sulla strada giusta. Purché sia chiaro – si sappia e si dica – che quelli cui si allude sono non tanto i diritti dei lavoratori quanto piuttosto i diritti dei cittadini che lavorano, od hanno il diritto di lavorare. C’è dunque un modo d’intendere lo statuto che, pur esortando a svilupparne tutte le implicazioni riguardanti il lavoratore in quanto cittadino, non è inconciliabile con quello, finora prevalente nella cultura sindacale, che promuove gli interessi del cittadino in quanto lavoratore. Vero è che lo statuto non rende obbligatoria la direttiva ermeneutica di familiarizzare interpreti ed operatori con una grammatica e una sintassi poco conosciute come sono quelle che antepongono alla figura del cittadino-lavoratore la figura del lavoratore-cittadino. Ma nemmeno può vietarla. In ogni caso, “per statuto dei diritti dei lavoratori”, come anticipava Giacomo Brodolini, bisogna intendere “un complesso organico di iniziative (...) dirette ad agevolare lo sviluppo della personalità dei lavoratori”. Come dire: c’è un Nuovo Mondo che aspetta ancora il suo Colombo. In effetti, nient’altro che questo aveva in mente lo scrivente: porre in luce che lo statuto del 1970 implicitamente, ma non oscuramente, segnala non solo la necessità della legge sulla rappresentanza sindacale che ancora non c’è, ma ne prescrive in parte anche i contenuti. Per questo, il relatore al Parlamento chiamato ad approvarla dovrà avere l’umiltà di confessare che si tratta semplicemente di riallacciare un discorso interrotto e completare un progetto incompiuto. Anzi, col candore di Massimo Troisi, dovrà anche dire: scusate il ritardo. Umberto Romagnoli
Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight. |