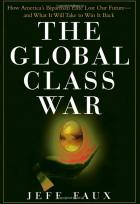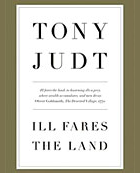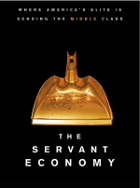Sottotitolo:
La complessa e variegata storia degli incontri tra il lavoro e il diritto dal corporativismo della Carta del Lavoro all'articolazione sull'asse della distinzione politica fra destra e sinistra.
Nella scuola di pensiero fondata da Gérard Lyon-Caen si insegna che il diritto del lavoro ha le caratteristiche della tela ricamata dalla sposa di Ulisse: “c’est Pénélope devenue juriste”. Difatti, non compie soltanto passi in avanti e nemmeno l’ultimo compromesso è definitivo: può essere rinegoziato al ribasso. Tuttavia, deve pur esserci una soglia al di sotto della quale il diritto che dal lavoro prende il nome si trasforma in altro-da-sé. Amenoché non l’abbia rubato, il nome che porta, e se ne sia impadronito, quantunque non gli fosse consentito di prendere solamente dal lavoro anche la ragione di esistere. In questo caso, nasconderebbe un tranello. Come Greenland, il nome assegnato alla Groenlandia. E’ sempre stata coperta di ghiaccio, ma venne chiamata Terra verde. Per attirarvi coloni.
Il sospetto che ho poc’anzi affacciato, se non è mai stato roba da visionari, mai come adesso appare fondato. Adesso che l’incontro del lavoro col diritto nella forma assunta durante quello che Tony Judt chiamava “il lungo momento socialdemocratico” dell’Europa del secolo XX è ormai un ricordo e c’è chi sostiene che sia irrepetibile.
Perché allora non cambiargli nome? Dopotutto, il capitale permise al lavoro di rompere un millenario silenzio a condizione di non alzare troppo la voce e di metabolizzare il divieto. Ad ogni modo, sono interessato meno al cambiamento del nome che a spiegarmi il suo successo. A mio parere, esso dipende dal fatto che la formula linguistica tralascia di enunciare come il diritto che dal lavoro prende il nome non può essere del lavoro più di quanto sia al tempo stesso del capitale.
Diversamente dalla storia immaginata, la storia reale del diritto del lavoro ci dice che il capitale ne ha avuto subito bisogno per disciplinare una manodopera riluttante e raccogliticcia, premiarla perché doveva anche essere punita: in breve, per insegnarle la laboriosità e, così facendo, legittimare la subalternità al potere di comando aziendale. Nell’ampia misura in cui non evoca tutto ciò, nessuno mostra di essere infastidito dalla formula lessicale ormai d’uso corrente; tutt’altro. In effetti, evoca una prospettiva di senso rassicurante e persino accattivante. Il che dipende da una sua qualità espressiva: i linguisti la chiamano forza mito-poietica.
Connaturata alla figura retorica dell’iperbole, essa predispone il diritto che dal lavoro prende il nome a divenire oggetto più di narrazioni mitologiche che di severe indagini storiografiche attente alla realtà normativa. Infatti, ha potuto prevalere la narrazione secondo la quale il diritto del lavoro c’è sempre stato, ci sarà sempre ed è ed è nato soltanto per proteggere il più debole degli interessi in gioco. Invece, l’insieme di queste proposizioni non costituisce altro che un luogo comune. Falsificante; una specie di depistaggio che ha deviato la cultura giuridica (e non solo questa).
Vero è che il lavoro delle masse in fuga dalla povertà cui in passato erano predestinate ha incontrato presto il diritto: poiché riempiva di sé il mondo reale, legislatori e giudici non potevano non occuparsi del lavoro. Tuttavia, nel diritto che gli capitava d’incontrare il lavoro non poteva riconoscersi. Per incontrare un diritto in cui potesse ravvisare qualcosa di realmente suo, ha dovuto aspettare che legislatori e giudici smettessero di trattarlo come una merce. Il che, però, che non ha potuto succedere prima che il lavoro uscisse dal buio d’una condizione d’insignificanza culturale cui si sommava l’ininfluenza politica. Un buio che nessuna lama di luce ha perforato fino a Novecento inoltrato.
Comunque, è certo che, se non lo interruppe l’emanazione della Carta del lavoro del 1927 che disegnava l’ideale fascista di una società pacificata, assistita e gerarchicamente ordinata, ma senza classi contrapposte, non poteva riuscirci neppure la contestuale pubblicazione di una rivista giuridica la cui testata riproduceva la medesima convenzione lessicale al centro della riflessione storico-critica che sto esponendo.
L’aveva fondata il ministro delle Corporazioni, Giuseppe Bottai, al quale non sfuggiva come la politica mussoliniana fosse anzitutto comunicazione. Pertanto, da uomo colto e politicamente scaltro non poteva non rendersi conto di servirsi di una metafora di sapore propagandistico, perché rovesciava l’immagine del corpus normativo di cui si occupava la rivista: ne celava la funzione, spostando l’accento dai propositi autoritari e repressivi al ruolo protettivo-emancipatorio. Soprattutto oggi, però, soltanto un tardo-pandettista potrebbe sostenere che il diritto del lavoro c’era anche in età corporativa.
Deliberata da un organismo sfornito di competenza legislativa, il Gran Consiglio del Fascismo, la Carta del lavoro fu egualmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma per una sola manciata di anni (tra il 1941 e il 1944) ha fatto parte dell’ordinamento giuridico. Dunque, tutti sapevano che non era una legge, ma molti giuristi giuravano che era già di per sé qualcosa di più: nel loro delirio intellettuale, il “di più” consisteva nella sua valenza para-costituzionale. Viceversa, la Carta del lavoro non poteva avere una portata superiore a quella del discorso d’investitura di un premier convinto di durare chissà quanto che presenta il suo governo con un documento ideologico-programmatico il quale, nell’annunciare l’inizio di una nuova era, prefigura i lineamenti che lo Stato assumerà.
Oggi, insomma, si direbbe che la Carta del lavoro aveva le caratteristiche del soft law, ossia di una metodologia regolativa in cui c’è più leggerezza che rigidità vincolistica. Ciò che anzitutto colpisce è la mancanza del rigore tecnico della legge di appena un anno anteriore che, con le caratteristiche (si direbbe oggi) dell’hard law, aveva gettato le basi costitutive del regime. Così, mentre l’intonazione affabulatoria del documento del ’27 rimandava all’esperienza successiva per sapere se, quando e come si sarebbero raggiunti gli obiettivi, la legge del ’26, legata al nome di Alfredo Rocco Guardasigilli del Regno di fresca nomina, precludeva alla regolazione del lavoro dipendente gli itinerari evolutivi che soltanto la libera misurazione dei rapporti di forza è in grado di tracciare.
Come dire: sequestrava la libertà sindacale proprio al fine di facilitare la gestione dei rapporti individuali di lavoro secondo i canoni vetero-liberali cari alla giusprivatistica dominante che garantivano l’intangibilità dell’ordinamento capitalistico della produzione. Pertanto, l’ideologia corporativa sopravvenuta non ha disturbato la preesistente e ormai consolidata communis opinio che comprimeva le regole dello scambio lavoro-retribuzione negli involucri confezionati dai privati nell’esercizio di un potere di autodeterminazione negoziale universalmente considerato come la più sacra manifestazione dell’individualismo economico e giuridico. Anche Alberto Asquini, il più politico tra gli allievi di Arturo Rocco, era del parere che la struttura del rapporto individuale di lavoro dovesse rimanere inalterata: “questa struttura resta sempre privata e contrattuale”.
Insomma, l’elementare verità con la quale bisogna fare i conti è che il lavoro possiede una tradizione giuridica infinitamente più lunga della sua specifica tradizione disciplinare. Quest’ultima comincia a formarsi tardi; ma non prima dell’affermarsi di criteri valutativi ostili alla riduzione degli incontri del diritto col lavoro ad occasioni per applicare una tecnica regolativa d’immodificabili rapporti tra diseguali. Non per caso, impallidisce al confronto con quella originata dalla proprietà il cui antichissimo diritto ha costituito la spina dorsale delle grandi codificazioni dell’età moderna. Ne differisce per durata, ampiezza e profilo. Assente fino all’avvento della grande industria, non varca i confini dell’angolo di mondo che chiamiamo Europa occidentale ed è legata ad un diritto venuto al mondo con la pretesa di aggiustarlo un po’. Una pretesa più manutentiva che rifondativa. La sua modestia, però, è più apparente che reale.
Malgrado l’origine plebea che ne fa un diritto a misura d’uomo, esso è incline a farsi ascrivere al lavoro; dal quale in effetti non prenderà soltanto il nome, quando gli riconoscerà la soggettività proteggendone gli aspetti attinenti alla libertà, alla sicurezza e alla dignità umana. Quando cioè sarà animato anche dalla convinzione che il lavoro si confonde coi beni di mercato proprio perché le sue ragioni sono estremamente vulnerabili al contatto con quelle dell’impresa. Infatti, è questo il salto di qualità che si rivelerà risolutivo nella storia degli incontri tra il lavoro e il diritto.
Si può tranquillamente escludere che la dirompente inclinazione fosse stata immaginata dai funzionari del Ministero della pubblica istruzione incaricati dal governo Badoglio di rifare il maquillage dell’ordinamento degli studi universitari, cancellando i segni linguistici del corporativismo che considerassero imbarazzanti. Ad essi si chiedeva soltanto la diligenza necessaria per consentire che, dall’anno accademico 1943-44, in tutti gli atenei del Regno – ovviamente, nell’invarianza di docenti e manuali per studenti – i corsi d’insegnamento di diritto del lavoro sostituissero quelli di diritto corporativo.
Però, la circostanza che sia stata pensata (e sia entrata nel lessico corrente) per designare una partizione dell’organizzazione didattica del sapere giuridico nelle Università dell’Italia (non ancora repubblicana, ma solo) post-corporativa non ha impedito che nel giro di pochi anni il segno linguistico acquistasse la validità conoscitiva che non aveva mai avuto. Ciò ha potuto accadere quando l’Assemblea costituente lo impiegherà testualmente (art. 35, comma 3) nel documento che solennizza l’inizio dell’età della de-mercificazione del lavoro, facendone il formante dello Stato: “L’Italia”, è l’incipit della costituzione, “è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.
Così, una volta uscita dallo stato di latenza, la strutturale ambivalenza del diritto del lavoro non solo giustifica la tendenza della cultura giuridica a dividersi sull’asse destra/sinistra. In un certo senso, la promuove, per la semplice ragione che le decisioni politiche che stanno a monte del diritto del lavoro non possono non alimentare consensi e dissensi. Pertanto, è inevitabile ed anche salutare che il conflitto d’interessi si trasferisca dal piano della produzione delle regole sul piano dell’interpretazione delle medesime: qui, cambiano i duellanti, ma le ragioni del contendere permangono intatte.
“Non saprò mai se sono un giurista prestato alla politica o un politico prestato al diritto”, diceva di sé Gino Giugni al quale, nel 2000, dedicai uno scritto col titolo Elogio del compagno professore. Con la franchezza che gli è abituale, Luigi Mariucci ha confidato alla sua rivista : “il diritto del lavoro ha costituito un succedaneo della mia inclinazione alla politica” ed “ha funzionato (…), come può funzionare il metadone per un tossico-dipendente”. “Il giurista fa politica”, è la secca conclusione di Federico Mancini, “e i suoi tempi sono quelli della politica”. Insomma, ciò che impedisce all’interprete di nascondere da che parte sta (se non, diceva lord Wedderburn, mentendo anche a se stesso) è la derivazione del diritto del lavoro da contesti dove destra e sinistra non sono mai state né saranno soltanto categorie da codice della strada.