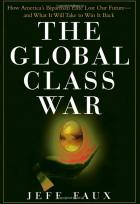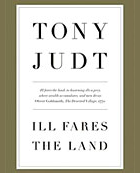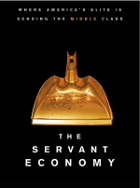Sottotitolo:
A dispetto dell'ironica definizione di "tutele crescenti", il licenziamento si pone come un “diritto” del datore del lavoro, e non invece un “potere” da regolare in relazione ai diritti del prestatore di lavoro.
1.La fase iniziale
La prima versione di quella che è poi diventata la legge delega n.183 del 10 dicembre 2014 si era annunciata in una veste accattivante, a partire dal titolo: il JobsAct, di sapore obamiano, induceva infatti a pensare che si trattasse di una legge per il lavoro, e non della ennesima (pseudo)riforma del mercato del lavoro. Nella news-letter dell’8 gennaio 2014 di Matteo Renzi, allora segretario del PD e non ancora presidente del consiglio, si annunciavano infatti un insieme di “misure concrete” finalizzate all’obiettivo di “creare posti di lavoro”.
Tra queste misure in primo luogo si indicavano sette piani industriali, in materia di cultura, green economy, nuovo welfare, edilizia, manifattura per ciascuno dei quali “il Jobs Act conterrà…le singole azioni operative e concrete e necessarie a creare posti di lavoro” , mentre in secondo piano venivano collocati gli interventi sulle “regole” tra le quali si segnalava oltre alla “semplificazione delle norme” la “riduzione delle forme contrattuali” da sostituirsi con un “processo verso un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutele crescenti”, nonché “un assegno universale per chi perde il posto di lavoro” e infine persino una “legge sulla rappresentatività sindacale e presenza dei rappresentanti eletti dai lavoratori nei CDA delle grandi aziende”.
Pareva in tal modo prendere corpo un indirizzo per così dire “concretista”, in netta discontinuità con la legislazione dell’ultimo ventennio sulla flessibilità del lavoro che è stata certamente una delle concause della crescente precarizzazione oltre a non aver prodotto alcun risultato positivo sul piano occupazionale E che quindi si sarebbe messo mano agli strumenti utili a incentivare una occupazione quanto meno “decente” e a contrastare le crescenti diseguaglianze e frammentazioni del mercato del lavoro.
Sarebbero andati in questa direzione, ad esempio, gli interventi diretti ad estendere il grado di copertura del sostegno al reddito per quanti cercano veramente lavoro; a costruire un sistema di servizi pubblici dell’impiego degno di questo nome, con una agenzia nazionale capace di raccordarsi con i centri per l’impiego che funzionano e di surrogare quelli del tutto inefficienti, diffusi, ahimè, soprattutto dove più servirebbero, vale a dire nel mezzogiorno; a introdurre una disciplina del salario minimo, che potrebbe realizzarsi estendendo erga omnes i minimi retributivi dei contratti nazionali di lavoro e prevedendo meccanismi di determinazione dell’”equo compenso” per i lavoratori parasubordinati o semi-autonomi; ad elaborare un testo unificato delle tipologie contrattuali, sfrondando l’attuale giungla dei contratti atipici e precari e incentivando la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Il tutto guardando, appunto, ai problemi reali, e restando distanti da ogni forma di feticismo legislativo, nella consapevolezza che qualche buon intervento normativo e soprattutto una forte innovazione sul piano delle politiche attive del lavoro possono aiutare la ripresa dell’occupazione, ma non sono certo risolutivi, in mancanza di robusti interventi anticiclici di politica economica e industriale e di una radicale modifica degli orientamenti dell’Unione europea. Purtroppo non è andata così.
2 .La prima contraddizione: la ulteriore liberalizzazione dei contratti a termine
Una prima contraddizione rispetto al progetto annunciato si verifica già nel marzo 2014. Il nuovo governo Renzi scinde in due parti gli interventi di politica del lavoro: da un lato si emana un decreto con cui si realizza una ulteriore liberalizzazione dei contratti a tempo determinato (decreto legge n.34 del 20 marzo 2014, convertito in legge n. 78 del 16 maggio 2014), dall’altro lato si vara un disegno di legge delega di riforma del mercato del lavoro.
Già la scelta dei due tempi è fortemente sospetta. Se davvero si intende realizzare la “riduzione delle varie forme contrattuali” e avviare un “processo verso un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutele crescenti” non si vede che senso abbia rendere ancora più agevole il ricorso ai contratti a termine, che costituiscono la forma di assunzione precaria di gran lunga prevalente, abolendo la cosiddetta “causale”, cioè la necessità di motivare le ragioni oggettive che giustificano il ricorso alle assunzioni temporanee, e prevedendo addirittura la possibilità di 8 proroghe e rinnovi senza causale nell’arco dei 3 anni (poi ridotti a 5 in sede di conversione parlamentare del decreto).
Né si comprende perché debbano essere rinviate le misure più strutturali alla consueta storia infinita delle leggi delega, destinate a produrre normative a cascata, e quindi ulteriori complicazioni legislative, con buona pace dei conclamati obiettivi di “semplificazione”, come è accaduto nella sequenza dei provvedimenti adottati dal governo Berlusconi dei primi anni 2000. La scissione evidentemente incoerente sul piano logico tra le due scelte è stata giustificata con la necessità di dare una “scossa” al mercato del lavoro agevolando le assunzioni a termine, per mettere mano poi ai provvedimenti strutturali. La “scossa” naturalmente non è arrivata, perché i dati sulla occupazione sono risultati, a fine dicembre 2014, ancora negativi e al limite della drammaticità rispetto alla occupazione giovanile, mentre intanto si avviava una sconcertante commedia nel percorso del disegno di legge delega.
3. La svolta dell’agosto 2014
Vale la pena di ricostruire con qualche pazienza l’iter del disegno di legge delega perché proprio negli andamenti del suo percorso regressivo si può meglio rintracciare l’intenzione autentica sottesa al progetto. Fino all’estate del 2014 il governo, e il presidente del consiglio in prima persona, hanno ripetuto il mantra “l’art. 18 non è un problema”. Questo ancora alla fine del luglio 2014, quando invece la componente di destra del governo (il cosiddetto Nuovo Centrodestra) ha di nuovo sollevato la bandiera della abrogazione dell’art. 18 come panacea di tutti i mali, in linea con il tentativo effettuato con la prima versione del disegno di legge delega n. 848 del 2002, sul punto poi frustrato per i noti motivi. Ma ancora in quel periodo il presidente del consiglio e con lui i componenti del suo staff, continuavano a ripetere il ritornello, appunto, del “non si parla dell’art.18”.
Poi, alla metà di agosto deve essere successo qualcosa perché il messaggio del presidente del consiglio si è letteralmente rovesciato nel contrario. Si è avviata infatti una ossessiva campagna mediatica all’insegna dei più consunti stereotipi sulla riduzione delle tutele come strumento di incremento occupazionale: da “il reintegro del licenziato è una cosa assurda”, a “l’art.18 è un fossile” (ignorando il fatto che la norma è stata radicalmente cambiata appena due anni fa dalla legge n. 92 del 2012 senza che questo abbia prodotto alcun effetto positivo, e anzi abbia reso forse più complicata la vita alle imprese e ai lavoratori), fino alla sconcertante affermazione secondo cui il licenziamento costituirebbe un “diritto” del datore del lavoro, e non invece un “potere” da regolare in relazione ai diritti del prestatore di lavoro.
E poi, la cosa in assoluto più inquietante: convalidare, da palazzo Chigi e non dalla penna di un polemista, che la reintegrazione del lavoratore a fronte del licenziamento ingiustificato nelle unità produttive di più di 15 dipendenti sia una forma di apartheid, come se il precariato e la disoccupazione fossero da imputare a quanti godono ancora di qualche residua tutela, legittimando così, concettualmente, una guerra tra poveri. Come se la storia non ci avesse mille volte insegnato che alimentare i conflitti tra le fasce deboli della popolazione implica la rottura di ogni legame di solidarietà e una anarchia sociale foriera di autentici disastri.
Resta ancora da chiedersi perché il governo, e il presidente del Consiglio in prima persona, abbiano voluto intestarsi questa radicale svolta sulle politiche del lavoro. E’ il risultato di un misterioso incontro estivo con il presidente del BCE? E’ la solita offa lanciata verso l’Europa, come fece il governo Monti a suo tempo? O c’è qualcosa di più: l’idea di realizzare uno sfondamento a destra, anzitutto culturale, umiliando ciò che ancora resta della “sinistra” in termini politici. E tutto ciò in una chiave inedita, che non si può definire semplicemente “neoliberista”, ma è qualcosa al tempo stesso di più e di diverso, che forse potrebbe essere nominata come una sorta di neo-peronismo in chiave fiorentina: vale a dire sorretta da una astuzia e una spregiudicatezza che avrebbero suscitato l’ammirazione di Machiavelli, letto nella sua interpretazione volgare, a prescindere cioè dal fondamento etico del suo ragionamento realistico sulla politica. Sono domande che andrebbero rivolte ai politologi più che ai giuslavoristi.
4. La legge delega/non delega
A partire da questo momento si è avviato un surreale percorso parlamentare. Per mesi, mentre al Senato si svolgeva l’esame del disegno di legge il governo e vari esponenti della sua maggioranza continuavano ad affermare la decisione di mettere mano alla disciplina dei licenziamenti ipotizzando le più varie modifiche, mentre lo stesso disegno di legge taceva del tutto sul punto. Il vertice di questa cosmica ambiguità è stato raggiunto in sede di prima lettura al Senato. Si è approvato un testo in cui nulla si diceva in materia, mentre il ministro del lavoro in contemporanea annunciava allo stesso Senato che comunque si sarebbe modificata la disciplina dei licenziamenti e da palazzo Chigi veniva addirittura emanato un comunicato in cui l’intenzione era ufficialmente confermata, facendo riferimento a non meglio definiti accordi intervenuti in sede politica.
Tale “sede politica” era costituita da un ordine del giorno approvato dalla direzione nazionale del PD nel novembre 2014 in cui si era deliberato che il disegno di legge si sarebbe dovuto correggere prevedendo “una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca l’incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare, previa qualificazione specifica della fattispecie”.
Quindi si trattava della seguente pretesa: lasciare del tutto muta la delega, salvo pretendere una potestà piena del governo di legiferare attraverso i decreti delegati, senza neppure chiarire se la nuova disciplina dei licenziamenti avrebbe riguardato tutti i lavoratori ovvero solo i nuovi assunti in base al cosiddetto “contratto a tutele crescenti”. Si è toccato in questo caso il punto più critico in termini di (ill)legalità costituzionale, data l’evidente violazione dell’art. 76 cost., poiché la legge delega non conteneva alcun riferimento al tema dei licenziamenti e quindi si era in assenza non solo di “principi direttivi” ma persino del riferimento ad “argomenti definiti”, di cui appunto alla norma costituzionale. Si era quindi in presenza di un caso clamoroso non di “eccesso di delega” ma persino di “eccesso dalla delega”, secondo le formulazioni della Corte costituzionale.
La verità è che il governo davvero pretendeva di lasciarsi le mani libere, in ragione sia dei contrasti con una delle sue componenti (ovvero con la linea oltranzista del cosiddetto Nuovo centrodestra) sia del dissenso della componente di “sinistra” dello stesso PD. Pretesa del tutto, com’è evidente, illegittima, come in sede di audizioni parlamentari alla commissione lavoro della Camera si è a iosa argomentato, anche da parte di chi scrive. Infine quindi ha prevalso almeno un briciolo di ragionevolezza e sul punto è stato introdotto un emendamento chiarificatore, che ha in sostanza recepito la ambigua formulazione del dispositivo dell’od.g. della direzione nazionale del Pd sopra richiamato, con la seguente formulazione: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tutele crescenti …escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, previo indennizzo certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamenti disciplinari ingiustificati” (così lett.c), comma 4, legge n.183 del 2014).
5. Il risultato finale: il decreto natalizio e il contratto a tutele (de)crescenti
Il risultato finale è stato poi sancito dal decreto natalizio, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre 2014 che può essere riassunto nei seguenti termini. Si può dire che Babbo Natale ha portato ai lavoratori la sostanziale eliminazione dell’art.18. La bozza di decreto stabilisce infatti che per tutti i nuovi assunti non ci sarà più la reintegrazione in caso di licenziamento ingiustificato, perché privo di motivo economico o disciplinare. Resta quindi confermato che la formula del “contratto a tutele crescenti” è del tutto arbitraria, e va derubricata in “contratto a tutele ridotte”. Infatti anche quando risulterà accertata la mancanza di una giustificazione del licenziamento il rapporto di lavoro sarà estinto e il giudice potrà solo stabilire una indennità di risarcimento da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità in relazione alla anzianità. Si dovrà quindi in ogni caso impugnare il licenziamento.
A quel punto tuttavia il datore di lavoro potrà proporre in alternativa e in via conciliativa una indennità, per giunta non tassabile, da un minimo di 2 a un massimo di 12 mensilità. L’uso disinvolto della leva fiscale ha quindi realizzato una nuova performance: si realizza infatti una sorta di incentivazione fiscale del potere di licenziamento ovvero una de-tassazione del paternalismo. Per ottenere dal giudice la reintegrazione al lavoratore resta una sola chance: dare la prova “diabolica” della discriminazione oppure dimostrare, nel caso dei licenziamenti per motivi disciplinari, “l’insussistenza del fatto materiale” contestato; il che significa che se si viene licenziati per “grave insubordinazione” e si dimostra che l’insubordinazione è stata invece “lieve” o “lievissima” questo non basterà ad essere reintegrati, perché il fatto materiale comunque sussiste e quindi si potrà ottenere solo il risarcimento.
Si abroga in questo modo anche il “principio di proporzionalità” delle sanzioni disciplinari introdotto, si badi, non dallo Statuto dei lavoratori ma addirittura dal codice civile del 1942. Il tutto viene esteso anche ai licenziamenti collettivi, con un evidente ”eccesso di delega”. Nulla si dice invece delle millantate riduzioni dei contratti precari e della proclamata abolizione di co.co.co. e co.co.pro., che al momento vengono invece ulteriormente istituzionalizzati, dato che il parallelo decreto sugli ammortizzatori sociali prevede per questi una modesta indennità di disoccupazione (denominata Dis-Coll), naturalmente “in via sperimentale per il 2015” “in attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali”.
Ma si tratta di promesse poco credibili: le affermazioni del presidente del Consiglio (“annulliamo cococo,cocopro e quella roba lì”, intervista a La Repubblica del 30 novembre 2014) sono infatti scarsamente attendibili. Le collaborazioni coordinate e continuative non possono essere abolite quando si tratti di forme legittime di lavoro autonomo. Piuttosto c’è da chiedersi che fine fanno le decine di migliaia di collaboratori assunti nella pubblica amministrazione, negli enti locali, nella sanità, negli enti di ricerca. Si assumono con contratti a termine? E come si risponde alla sentenza della Corte europea di giustizia che dichiara illegittima la reiterazione delle assunzioni a termine nella scuola? Si possono invece abolire i co.co.pro. che furono introdotti dalla cosiddetta legge Biagi proprio per contrastare l’abuso dei co.co.co. ed estendere alcune tutele. Ma su questo sarà difficile trovare l’accordo con quelle componenti della maggioranza di governo (NCD) a cui si deve proprio l’introduzione della ampia tipologia di contratti temporanei e atipici effettuata con il dlgs. n.276 del 2003. Per questo si dovrà attendere un prossimo e futuribile decreto. Per l’intanto i licenziati si dovranno accontentare del voucher di “ricollocazione” presso agenzie pubbliche o private, da disciplinare tuttavia con altri successivi decreti e, si suppone, regolamenti attuativi di cui la legislazione italiana continua a ingolfarsi in nome della mitica semplificazione.
6.Valutazioni conclusive
In conclusione è evidente che siamo di fronte ad una vera e propria commedia degli inganni. Basti considerare la singolare semantica del cosiddetto “contratto a tutele crescenti”. Per l’Unione Europea il contratto a tutele crescenti dovrebbe consistere in un contratto che inizia “con un livello di base di tutela del lavoro” e in cui la protezione si accumula “progressivamente via via che il lavoratore occupa un posto di lavoro fino a raggiungere una protezione piena” (Consiglio europeo del dicembre 2008). Qui invece si stabilisce che per tali contratti viene esclusa, per sempre, la tutela “piena” prevista per i lavoratori già occupati su un istituto cruciale come quello del licenziamento. La definizione di contratto “a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio” è quindi puramente strumentale.
Qui non c’è nulla che “cresca”, tranne l’indennità che può essere stabilita dal giudice ove il licenziamento impugnato sia ritenuto ingiustificato, o che sia offerta in via conciliativa, in una cifra minima inferiore, dallo stesso datore di lavoro. Il titolare di questo contratto è quindi come un bambino che non diventa mai adulto, un apprendista a vita. Un secondo inganno sta nel presentare il nuovo contratto come strumento di riduzione del precariato e quindi di estensione dei diritti. Infatti l’intenzione di ridurre le tipologie contrattuali è puramente declamata ma per nulla realizzata, come sopra osservato. Se dunque gli “interventi di semplificazione, modifica o superamento delle…tipologie contrattuali” restano del tutto ipotetici e virtuali, certa è invece l’introduzione di un nuovo dualismo nel mercato del lavoro, con buona pace delle tante giaculatorie in tema di superamento delle barriere tra insiders e outsiders.
Sono evidenti, e da più parti già segnalati, gli effetti distorsivi che questa disparità di trattamento determinerà nelle dinamiche del mercato del lavoro: da un lato verrà disincentivata la mobilità volontaria dei lavoratori già occupati, dall’altro lato si incentiverà l’interesse delle imprese a liberarsi di questi ultimi per sostituirli con lavoratori assunti con il nuovo contratto, il quale oltre ad assicurare una più agevole licenziabilità consente anche di fruire della decontribuzione triennale e dello sconto Irap previsti in parallelo dalla legge di stabilità. Il disegno mira evidentemente a determinare una progressiva eutanasia dell’art.18, a seguito vuoi del licenziamento dei lavoratori in servizio vuoi del normale turn over.
Ma fino a quando l’effetto sostitutivo non verrà completato si registrerà una vistosa differenziazione di trattamento tra quanti sono già titolari di un contratto di lavoro e tutti coloro che verranno assunti dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Accadrà quindi che vi saranno due tipi di lavoratori, occupati nella stessa impresa, con la stessa qualifica e le medesime mansioni, ma con un trattamento differente su un istituto cruciale del rapporto di lavoro come quello relativo ai limiti del potere di licenziamento: il che significa che se licenziati per la medesima fattispecie gli uni potranno ottenere, in assenza di giustificato motivo, la reintegrazione del rapporto, mentre per gli altri il licenziamento ingiustificato verrà solo monetizzato.
C’è da chiedersi in quale strana accezione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza possa trovare fondamento una disparità così macroscopica di trattamento, la cui legittimità dovrebbe essere argomentata sulla base del fatto che uno dei due lavoratori a suo tempo, e magari anni prima, era stato assunto con lo “speciale” “contratto a tutele crescenti”. Di questo si dovrà occupare evidentemente la Corte Costituzionale. Per l’intanto si può tranquillamente affermare, che si tratta di una differenza di trattamento “ingiusta”: “questo sarebbe ingiusto”, aveva risposto infatti lo stesso presidente del Consiglio a chi gli chiedeva, qualche tempo fa, se l’art.18 sarebbe stato modificato e/o abrogato solo per i nuovi assunti (intervista a La Repubblica del 30 settembre 2014).
Restano da osservare le intime contraddizioni sottese alla intera operazione, rese ora ulteriormente evidenti dal decreto natalizio. Dietro lo schermo del “contratto a tutele crescenti” ciò che si realizza è in effetti una ulteriore modifica organica dell’art.18, sia pure riferita ai soli nuovi assunti. Tale modifica funziona così. Per i licenziamenti economici (ovvero per giustificato motivo oggettivo) viene esclusa in ogni caso la possibilità della reintegrazione sostituita da un indennizzo. E’ bene ricordare che il diritto vigente (legge Monti-Fornero, n.92 del 2002) prevede in questo caso la reintegrazione in caso di “manifesta insussistenza” del motivo economico.
Ora quindi è come se si dicesse che per gli assunti con il nuovo contratto la reintegrazione non è possibile e va sostituita con la monetizzazione anche ove il motivo economico fosse “manifestamente insussistente”, vale a dire pretestuoso, in frode alla legge. Il che è palesemente inammissibile, dato che il licenziamento immotivato in questo caso sarebbe nullo. E tuttavia lo stesso decreto natalizio non può fare a meno di confermare la reintegrazione nei casi in cui il giudice “dichiara la nullità del licenziamento discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge” (art2, primo comma). C’è quindi qui una contraddizione evidente tra l’intenzione dichiarata (liberalizzazione totale dei licenziamenti economici) e la possibilità di realizzarla effettivamente, dato che non siamo nel 1965 quando l’ordinamento ancora consentiva il licenziamento libero, ma nel 2014 quando comunque vige un obbligo di motivazione e giustificazione del licenziamento, cui vanno aggiunti i vincoli in materia di tutela contro i licenziamenti ingiustificati e i divieti di discriminazione stabiliti dal diritto della Unione Europea.
Nel caso poi dei licenziamenti disciplinari (per giustificato motivo soggettivo) va osservata la seguente discrasia tra legge delega e il decreto natalizio. La legge delega, mutuando il già richiamato o.d.g. della direzione nazionale del PD, rinviava ai fini del mantenimento del diritto alla reintegrazione alla definizione di “specifiche fattispecie di licenziamento ingiustificato”. La formula appariva singolare e di improbabile attuazione, dato che l’universo empirico difficilmente si fa rinchiudere in disposizioni di carattere tassativo, come dimostrano i contratti collettivi di lavoro che contengono l’elencazione delle infrazioni che legittimano il ricorso alle sanzioni disciplinari, salvo aggiungere la clausola di stile per cui si tratta di riferimenti puramente esemplificativi. In sede di decretazione gli estensori si devono essere accorti dell’aporia in cui si era caduti, cosicchè il decreto natalizio ha cambiato registro: invece che indicare le “singole fattispecie” per le quali mantenere la reintegrazione questa è stata riservata al solo caso della “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Il che, mentre per un verso appare una sorta di lodo in favor delle tesi datoriali rispetto a un contenzioso in atto (cfr. da ultimo Cass. n.23669 del 2014), pone intanto un problema di incoerenza con quanto previsto dal dispositivo della legge delega e solleva, come sopra osservato, una questione di costituzionalità in ordine alla violazione dei principi generali di “proporzionalità” e “adeguatezza”.
C’è da chiedersi come di tutto questo si possa dare una lettura positiva. Eppure si tende ad accreditare l’idea, assunta quasi a senso comune, che ciò serva davvero a contenere il lavoro precario, riconducendolo a un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato sia pure meno tutelato sul piano della disciplina del licenziamento. In realtà, se ben si guarda, il disegno qui descritto assomiglia a quello posto alla base della codificazione del 1942: allora le imprese volevano assicurarsi la disponibilità della forza lavoro, specie per le fasce più qualificate, e quindi fu affermata la regola comune della assunzione con il contratto di lavoro a tempo indeterminato rafforzato da varie forme di fidelizzazione, compresa l’indennità di anzianità (al tempo prevista solo in assenza di un licenziamento “per colpa” del lavoratore), salvo assicurare il licenziamento libero, mediante preavviso (art.2118).
Oggi di certo la tecnica del licenziamento ad nutum non è praticabile, in ragione dell’obbligo di motivazione introdotto dalla legge n. 604 del 1966, nonché della complessa evoluzione dei divieti antidiscriminatori, sollecitati in particolare dal diritto della U.E. E tuttavia la logica è la medesima. Al fondo c’è una idea persistente: quel che conta è la libertà d’impresa, questo è il valore centrale, in un rovesciamento evidente dei principi costituzionali o, più semplicemente, in una banale traduzione della teoria schumpeteriana dello sviluppo sociale. Senonchè le cose sono più complicate. Si affermano nuove linee di frattura. Gli andamenti della crisi sul piano globale impongono altre urgenze, che hanno resi obsoleti i paradigmi della autoregolazione dei mercati, grazie al provvidenziale egoismo individuale che anima la salvifica “mano invisibile”, rendendo invece più attuali le “teorie dei sentimenti morali” di Adam Smith. In altri termini, si afferma la necessità di una nuova regolazione pubblica, vuoi che si tratti di contrastare le tendenze recessive sul piano economico, ovvero di fare fronte alla gigantesca sfida di fronte a cui è posto l’intero mondo occidentale: quella di rendere compatibile l’accoglienza dei nuovi immigrati con i valori sanciti dai principi dell’89, che in concreto si traducono nei termini possibili di una nuova lotta per l’eguaglianza e in una politica di contrasto alle crescenti disuguaglianze sociali che sono alle radici delle tensioni che si muovono sulla scena globale.
Da questo punto di vista i provvedimenti qui esaminati assumono un evidente sapore retro, adottati da un governo che peraltro su altri piani ha mostrato invece di comprendere ciò che si muove nel nuovo corso: dalle decisioni in materia di salvataggio della industria dell’acciaio (vicenda Ilva) agli interventi in materia di incremento del reddito dei lavoratori dipendenti (cosiddetti 80 euro). La vicenda qui osservata peraltro non è conclusa, anzi è appena all’inizio. Restano da sciogliere i nodi relativi al pubblico impiego, poiché infine il governo si è accorto che le modifiche all’art.18 non possono riguardare solo i 6 milioni di lavoratori del settore privato occupati nelle imprese con più di 15 dipendenti, ma anche i 3 milioni di pubblici dipendenti, salvo restaurare una distinzione addirittura di status tra lavoro privato e lavoro pubblico.
Poi occorrerà verificare come verranno attuate, nei prossimi decreti legislativi, le norme della legge delega in materia di demansionamento e controllo a distanza sui lavoratori. E infine l’ultima questione, quella che si riassume nella formula del “codice semplificato” e che nella legge delega è indicato nei termini di un “testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro” (comma 7). Si tratterà di vedere se tale norma verrà intesa nel modo corretto in cui andrebbe interpretata, ovvero come un riferimento alla elaborazione di un testo unico delle diverse tipologie di contratti di assunzione, oppure come la pretesa di riscrivere ab imis, in chiave vetero-liberista, l’intero statuto normativo del contratto di lavoro. Adottare la seconda delle opzioni qui indicate significherebbe perseguire testardamente l’idea, innumerevoli volte ormai smentita dai fatti, per cui ciò che serve è il lavoro volatile, alla carta, reso totalmente dipendente dalle esigenze immediate dell’impresa. Salvo, subito dopo, discettare di “partecipazione” e “coinvolgimento” dei lavoratori, come se la cooperazione non richiedesse la realizzazione di un pre-requisito essenziale: la qualità e la ragionevole stabilità del lavoro. Ma di questo si vedrà nei prossimi mesi.