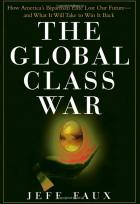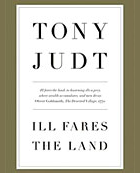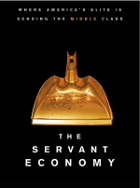Sottotitolo:
Crollato il fascismo, era pressoché invitabile che nella transizione alla democrazia prevalesse l’incertezza e, unitamente all’entusiasmo, grande fosse lo spaesamento. Il sindacato infatti era tornato a essere un soggetto senza uno statuto giuridico.
1. Nel mosaico composto dalle quattro-norme-quattro della costituzione – gli artt. 39, 40, 46 e 99 – ove sono disegnati profilo e ruolo del sindacato non si fatica a riconoscere il precipitato di una visione d’insieme come potevano averla interiorizzata gli uomini migliori della Costituente – a cominciare da Giuseppe Di Vittorio – negli anni della dittatura trascorsi in esilio o al confino, da prigionieri politici o da stranieri in patria. Pensavano ad un soggetto che si distingue dal partito in ragione di una tendenziale separatezza tra la sfera politica, da cui il sindacato farebbe bene a starsene il più lontano possibile, e la sfera sociale che delimiterebbe il suo perimetro naturale. Lo vedevano fiondato come una catapulta sui tavoli della contrattazione, giorno e notte, e al tempo stesso portatore di competenze sufficienti a giustificarne la cooptazione in un organismo di consulenza del Parlamento e dei governi. Lo immaginavano disciplinato, anche se conflittuale, e coinvolto nella gestione delle imprese per promuovere l’“elevazione economica e sociale del lavoro”.
2. L’art. 39 è figlio dell’idea che la libertà di cui gode il sindacato non è incompatibile con l’integrazione del medesimo nell’ordinamento dello Stato mediante leggi che gli attribuiscano la facoltà di codeterminare su base consensuale le condizioni di lavoro e di vita di masse di cittadini che non lo hanno scelto come proprio rappresentante; un privilegio che di per sé giustifica forme di controllo pubblicistico, per blande che possano essere. Infatti, nell’art. 39 si profila la sagoma di un soggetto che, se non stipula contratti, perde la sua identità e, se non può stipularne di valevoli erga omnes, si considera menomato. Pertanto, i costituenti pensano che sia fortemente interessato a risparmiarsi angosce esistenziali del genere. Diversamente, non ragionerebbero nel presupposto che si sarebbe comportato in modo da persuadere lo Stato a concedergli la legittimazione ad esercitare il potere para-legislativo di regolare l’universo dei rapporti di lavoro. Lo Stato, insomma, era sicuro che il sindacato gli avrebbe chiesto di essere “registrato” negli appositi uffici pubblici e annoverato tra i soggetti privati meritevoli del suo “riconoscimento”.
Stando così le cose, non è una forzatura collocare l’art. 40 in un rapporto di finalizzazione stretta con l’obiettivo, totalizzante e apparentemente irrinunciabile, che lo Stato gli consente di perseguire quasi per delega. Con l’encomiabile sobrietà espressiva propria dei principi fondamentali della Repubblica, la norma riconosce il diritto di sciopero, pur prescrivendo che esso non possa essere esercitato se non “nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Però, benché sia vero che fecero discutere norme come quelle proposte da un ministro (social-democratico) del lavoro della prima metà degli anni ‘50 in base alle quali lo sciopero può essere proclamato solo da sindacati riconosciuti dallo Stato, solo a contratto collettivo scaduto e solo per modificarne le clausole, non credo che si possa dire che il Parlamento non le approvò perché temeva che sarebbero state travolte da una valanga di censure d’incostituzionalità; all’epoca, semmai, prevaleva l’opinione opposta e, comunque, l’Alta Corte non era ancora stata istituita.
Il fatto è che l’esecutivo ritirò il disegno di legge, perché giudicò strategicamente più importante ai fini della governabilità del paese impegnarsi sul terreno di una legge elettorale che correggesse il sistema proporzionale a vantaggio del maggioritario (ricordo che la c.d. legge-truffa, come la chiamava l’opposizione, è del 1954). Fatto sta che il legislatore ha attuato l’art. 40 limitatamente all’area dei servizi pubblici essenziali, e soltanto nel 1990, con la medesima cautela peraltro cui era ispirato il suo generale astensionismo in materia sindacale. Per molti decenni, quindi, lo spazio lasciato vuoto dal legislatore è stato massicciamente occupato dalla giurisprudenza di merito, di legittimità e soprattutto costituzionale.
Anzi, è a quest’ultima che si deve lo smantellamento (terminato soltanto negli anni ‘70) delle norme fasciste che criminalizzavano il conflitto collettivo. Insomma, le regole del conflitto collettivo – come, del resto, quelle riguardanti la contrattazione collettiva – sono il risultato di una delle più estese forme di supplenza giudiziaria che si siano mai viste. Un risultato voluto dai pubblici poteri cui non poteva sfuggire che la popolazione giudiziaria era stata educata, in vigenza di un severo codice penale, a valutare negativamente ogni forma di sciopero e dunque poteva contare su di essa come argine di contenimento della conflittualità collettiva. Soltanto in seguito trasmisero il messaggio che, nel mutato clima che accompagnava l’emanazione dello statuto dei lavoratori, la magistratura avrebbe dovuto ripensare il suo atteggiamento mentale. Infatti, se l’art. 28 fornisce i mezzi necessari per sanzionare il comportamento anti-sciopero dell’imprenditore, ciò vuol dire che, per il legislatore, lo sciopero – prima ancora d’essere oggetto di una regolamentazione legale – deve essere protetto.
Dal canto suo, neanche l’art. 46 cost. che preannuncia una legge per stabilire “modi e limiti” del diritto dei lavoratori a “collaborare alla gestione delle aziende” ha mai ricevuto attuazione; tranne che in alcuni episodi locali di breve durata e unicamente su base consensuale, incapaci da soli di creare le premesse per far uscire la “democrazia industriale” dal limbo concettuale di cui si continua a favoleggiare. Insomma, la norma costituzionale è rimasta un guscio vuoto. Un po’ perché è inesistente la disponibilità degli imprenditori ad attribuire alla “collaborazione” un significato meno paternalistico di quello che il medesimo termine assume nell’ambito della definizione codificata dell’ideal-tipo di lavoratore dipendente (art. 2094) e un po’ perché la sola forma partecipativa richiesta finora dal sindacato è quella formalizzata in procedimenti di informazione e consultazione preventiva relativamente a decisioni della direzione aziendale che producono effetti sulle maestranze. Quello di cadere nell’oblio è un destino umiliante per qualsiasi norma; figurarsi se la norma fa parte di un testo costituzionale.
Tuttavia, la sorte toccata all’art. 99 è inverosimilmente peggiore non solo rispetto a quella toccata all’art. 46, ma anche rispetto alle più nere previsioni. E ciò sebbene, tra tutte le norme costituzionali che più direttamente si rivolgono al sindacato, sia stata l’unica ad essere diligentemente attuata. E’ dal 1957 che è entrato in funzione un organo ausiliario dello Sato, e specificatamente di consulenza delle Camere e del governo in materia di legislazione economica e sociale, composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive. Orbene, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – questa è la sua denominazione – ha rischiato di essere soppresso in occasione di una complessa revisione costituzionale che si proponeva inter alia di “ridurre i costi della politica”, con la mortificante etichetta che ne fa il prototipo degli enti inutili.
Respingendo la riforma costituzionale, l’esito del referendum del 4 dicembre 2016 lo ha mantenuto in vita; anche se nessuna voce autorevole si è levata a suo supporto durante l’infuocata campagna referendaria e soltanto una piccola minoranza degli elettori sapeva che l’istituzione, vittima di una inarrestabile atrofia progressiva nella generale indifferenza, di fatto era già deceduta. Come dire che, nato se non per caso di sicuro in base a calcoli inesatti, soltanto per caso è scampato al pericolo di un traumatico decesso.
Guardare la quaterna costituzionale è come sfogliare il libro dei sogni. Colpisce infatti lo scarto tra il proposito dei costituenti di valorizzare il lavoro in maniera esponenziale e una progettualità giuridico-istituzionale che mette a disposizione del sindacato la medesima cassetta degli attrezzi rinvenibili nell’agenda politica dell’età giolittiana: in particolare, il contratto collettivo valevole erga omnes (che era rimasto un desiderio insoddisfatto) e una camera di rappresentanza degli interessi economico-professionali (che, nel 1902, la legge denominava Consiglio superiore del lavoro, riempiendo così di gioia Filippo Turati perché apparteneva ad un periodo della storia d’Italia in cui, non essendoci ancora il suffragio universale, l’innovazione istituzionale assumeva un significato d’alto profilo).
Autenticamente inedito è soltanto il diritto di sciopero. Non è certamente poco, segnatamente se si considera che l’Assemblea costituente ruppe deliberatamente il principio della parità delle parti sociali nell’uso dei mezzi della lotta sindacale: la serrata infatti è un disvalore, costituisce un illecito contrattuale e perciò deve accontentarsi della sola depenalizzazione. Dunque, l’art. 40 non è certamente poca cosa. Ma è tutto e, per quanto la cosa possa apparire paradossale, è stato determinante proprio in ragione del vuoto legislativo; un vuoto colmato dal ceto professionale degli operatori giuridici che, superate le iniziali resistenze, in maggioranza hanno gradualmente aderito a un’interpretazione del telegrafico disposto costituzionale sempre meno arcigna nei confronti dell’autotutela collettiva.
A questo punto, è plausibile concludere che la storia giuridico-sindacale del dopo-costituzione non può aver gratificato i costituenti. Ciononostante, nemmeno può dirsi che autorizza senz’altro ad accostarli al tenero personaggio creato da Antonio Tabucchi. “…’La smetta di frequentare il passato, cerchi di frequentare il futuro’…Che bella espressione, disse Pereira, ‘frequentare il futuro’, che bella espressione, non mi sarebbe mai venuta in mente…”. Piuttosto, può dirsi che l’en plein della quaterna immaginata richiede tempi lunghissimi. Dopotutto, l’inevitabile non succede mai, ha scritto qualcuno; l’imprevisto sempre.
3. Chissà cosa avranno pensato di me gli studenti che seguivano il mio corso universitario. Come minimo avranno pensato che fossi un fan del fondatore del teatro dell’assurdo quando ascoltavano il mio racconto dell’art. 39 “inattuato, inattuabile e tuttavia attuale”. Alcuni in effetti mi guardavano trasecolati, non a torto. Per questo, mi industriavo a raccontare che le parti sociali avevano imparato ad appassionarsi al gioco consistente nel restare fuori della costituzione senza, per ciò stesso, mettersi contro e che vi erano state costrette perché nel retro-pensiero degli stessi costituenti che lo scrissero l’art. 39 è una inutile necessità. Naturalmente, mi ci voleva un po’ di tempo per darne una spiegazione convincente. Perlomeno, il tempo di durata di una lezione accademica.
Crollato il fascismo, era pressoché invitabile che nella transizione alla democrazia prevalesse l’incertezza e, unitamente all’entusiasmo, grande fosse lo spaesamento. Il sindacato infatti era tornato a essere un soggetto senza uno statuto giuridico che lo distinguesse dagli altri corpi intermedi e il contratto collettivo riprecipitava nella condizione in cui lo trovò il fascismo e da cui il fascismo lo aveva tirato fuori con un’energia e una lucidità ammirate dappertutto: nelle aule giudiziarie, nelle Facoltà di giurisprudenza delle Università del Regno, nelle piazze. Anche all’estero. Infatti, come il sindacato del ventennio si porta dentro la bipolarità che ne fa un soggetto incaricato di rappresentare gli iscritti in base agli ordinari meccanismi previsti dal diritto civile e, al tempo stesso, lo legittima a sostituirsi al legislatore per assicurare alla generalità dei lavoratori eguali trattamenti a parità di lavoro, così il contratto collettivo (segnatamente, quello di categoria) ha natura duale: ha il corpo del contratto e l’anima della legge, scriveva Francesco Carnelutti.
Però, i conti hanno sempre faticato a quadrare. Lo Stato non ha mai smesso di detenere il monopolio del diritto positivo; può sì disporsi a delegarne la produzione, ma soltanto a soggetti di cui abbia motivo di fidarsi: diversamente, vale il principio secondo il quale il contratto ha forza di legge solamente tra le parti. Il fascismo è in grado di far tornare i conti con relativa facilità perché riconosce soltanto i sindacati che si lasciano ingolosire dalla legge del 1926 scritta dal giurista e ministro guardasigilli Alfredo Rocco. Una legge che valorizza al massimo le specificità che contraddistinguono il sindacato e il suo prodotto di più largo consumo, rispettivamente, nel panorama dei fenomeni associativi e nell’ambito delle manifestazioni dell’autonomia negoziale dei gruppi. Le valorizza però per strumentalizzarle, facendone un comodo pretesto per soddisfare la voracità di uno Stato padre-padrone.
La difficoltà di far quadrare i conti non può non ripresentarsi in tutta la sua grandezza in un regime di libertà sindacale. I costituenti lo sanno, ma se la cavano addossando al legislatore il compito di andare alla ricerca di un equilibrio compatibile coi principi fondativi dei regimi democratici tra la dimensione privato-sociale e la dimensione pubblico-statuale tanto del sindacato quanto della contrattazione collettiva. Questo è un aspetto essenziale della questione aperta in sede costituente. Se viene espunto dal dibattito, come pregiudizialmente avveniva nella scuola di Fiesole dove la Cisl formava i suoi quadri, si finisce per sottoporre il progetto costituzionale ad una narrazione che ne enfatizza le affinità con la soluzione adottata dal fascismo.
È un rischio di cui, tutto preso dal dissacrante furore di deporre l’art. 39 in una bara da sigillare con cura, Federico Mancini non si curò scrivendo (nel 1963) la sua prolusione accademica in coincidenza con la presa di servizio nella cattedra di diritto del lavoro nella Facoltà giuridica bolognese. Enfatizzò affinità involontarie e superficiali e trascurò che i costituenti, proprio perché prefiguravano un assetto dei rapporti tra Stato, sindacati e lavoratori senza precedenti nella storia dell’Italia unita, non andarono oltre un annuncio del tipo “armiamoci e partite”. Il fatto è che l’equilibrio tra la dimensione privato-sociale e la dimensione pubblico-statuale che i costituenti impongono di instaurare nelle forme del diritto positivo non è in rerum natura e, comunque, si rivelerà impossibile dopo la rottura dell’unità sindacale originata dal Patto di Roma del 1944.
La Cgil unitaria si dissolve allorché l’anti-fascismo, che ne era stato il collante durante la Resistenza, perde la centralità sia nel pensiero che presiedeva all’azione politica sia nel sentimento popolare che percorre il dopo-Liberazione a vantaggio dell’anti-comunismo che, anzi, diventa il nuovo collante. Acuta infatti è la percezione della necessità di completare sul versante della rappresentanza sociale del lavoro la conventio ad excludendum pattuita tra i partiti che formano i governi centristi guidati dalla Dc nel clima della guerra fredda destinata a spaccare in due il mondo fino alla fine dell’ottavo decennio del secolo XX. È per blindare un sistema politico bloccato che si opta per l’accantonamento di una larga porzione del mosaico normativo sulla base del quale ho cercato poc’anzi di ricostruire la cultura giuridico-sindacale dei costituenti. Quella imboccata, insomma, è la strada della de-costituzionalizzazione del sistema sindacale. La scelta è falsamente neutrale.
Come accade sul versante del conflitto collettivo caratterizzato dall’inattuazione dell’art. 40, con la disapplicazione dell’art. 39 lo Stato finge di non voler ingerirsi nella dinamica sindacale; in realtà, si propone di controllarla indirettamente, con strumenti più efficaci e penetranti di quelli consentiti dai costituenti. In fondo, per stipulare contratti collettivi valevoli erga omnes (con un potere decisionale proporzionato alla propria consistenza associativa) ai sindacati sarebbe bastato superare un test di democraticità condotto sui loro ordinamenti interni da qualche distratto funzionario pubblico: il che dà la misura di quanta fiducia i padri costituenti riponessero nella libertà sindacale. Una fiducia illimitata.
Una fiducia che, invece, i governanti dell’epoca non potevano permettersi. Tranne che nei confronti della Cisl: che era l’avamposto piazzato in partibus infedelium su cui la Dc faceva assegnamento per dare al mondo delle imprese un competitore più collaborativo che conflittuale. Di sicuro, diffidavano della Cgil, appiattita sui partiti di sinistra il più grosso dei quali, il Pci, ne faceva la cinghia di trasmissione di una strategia politica di conquista del potere. D’altra parte, anche questo sindacato, il solo virtualmente interessato all’attuazione dell’art. 39 in ragione della sua superiore consistenza associativa specialmente nel settore industriale, si convinse in fretta che non era il caso di insistere. Sapeva che governi e Parlamenti non avrebbero dato l’OK all’attuazione dell’art. 39 se non marginalizzando il diritto di sciopero sia per alleggerirne il costo economico che per dissuadere i sindacati dal prendere iniziative contrastanti con la strategia dei partiti o, semplicemente, ne compromettessero il primato. Per questo, si diffuse l’opinione che meno si legifera meglio è. Per tutti. Né la Uil aveva interesse a contrastarla; a lei bastava consolidarsi, come in effetti le riuscì perché era sufficientemente scaltra per massimizzare i benefici connessi all’ambiguità di ruolo che solitamente contraddistingue le terze forze.
Ecco: è con parole simili a queste che per mezzo secolo ho descritto ai miei studenti le ragioni dell’inattuazione dell’art. 39, senza trascurare di informarli che il linguaggio corrente era criptico. Infatti, si preferiva dire che quella praticata era una contrattazione collettiva di diritto comune. Viceversa, per quest’ultimo la contrattazione collettiva era un’entità sconosciuta. Perciò, l’ammiccamento lessicale nascondeva la più elementare verità e la verità è che si era in presenza della privatizzazione integrale del fenomeno sindacale senza regole precostituite né presidi legali. Ma la necessità, come si suol dire, aguzza l’ingegno. Il proverbiale adagio vale anzitutto per la giurisprudenza che s’inventa argomenti capaci di risolvere problemi tecnico-giuridici che solo una legge sindacale di attuazione dell’art. 39 potrebbe risolvere.
La supplenza giudiziaria infatti risolve il problema dell’inderogabilità del contratto collettivo, perlomeno da parte degli iscritti ai sindacati stipulanti, e quello della sua efficacia generale sia pure limitatamente alle tariffe salariali mediante un’interpretazione creativa dell’art. 36 cost. che riconosce il diritto ad una retribuzione giusta e sufficiente. Nel complesso, la giurisprudenza ottiene un risultato prossimo a quello ottenibile attraverso il riciclaggio degli automatismi previsti dalla legge del 1926 e dunque mimava la medesima esperienza giuridica che le era più familiare. Ogni riciclaggio, però, è un ripiego. Per apprezzabile che possa essere la loro praticità, gli espedienti sono culturalmente poco dignitosi. Nel nostro caso, frequenza ed ampiezza dell’uso che se ne faceva dimostrano che i sindacati erano mortificati dall’esiguità delle risorse offerte dalla tecnica giuridica disponibile: l’habitat nel quale dovevano agire era sospeso fra un passato che non voleva passare e l’indeterminatezza di un futuro che tardava a materializzarsi.
4. Il sindacato degli anni ’50 non era tenuto a saperlo, ma si muoveva sul terreno più adatto a riattualizzare la teorizzazione di uno dei maggiori giuristi del Novecento sull’esistenza di ordinamenti ai margini di quello statuale, giustapposti e paralleli al medesimo, se non proprio alternativi. Riflettendo sulla crisi dello Stato e del suo assolutismo, Santi Romano era giunto a scoprire che l’antica massima ubi societas ibi ius non significa soltanto che la società non può fare a meno del diritto prodotto dallo Stato: significa anche che la società produce diritto, sia pure extra-legislativo. E ciò perché la dinamica spontanea dei gruppi privati è in grado di costruire una legalità non meno vincolante, e talora più efficiente, di quella statuale. Come dire che il sindacato degli anni ’50 ha bisogno di qualcuno capace non solo di giustificare dal punto di vista teorico l’inattuazione dell’art. 39, ma anche di argomentare che il suo congelamento non è un male in sé.
E’ toccato a Gino Giugni dimostrare, presagendo che un’organica legge sindacale sarebbe arrivata chissà quando, come l’adesione acritica all’ottocentesca concezione stato-centrica del diritto penalizzi la vitalità dell’autonomia privato-collettiva nella misura in cui ne nega arbitrariamente l’attitudine a creare un ordinamento iure proprio. La sua, insomma, non era che un’ipotesi di lavoro giustificazionista ed insieme predittiva. Ma ebbe uno straordinario successo. E ciò perché si basava su presupposti condivisibili e largamente condivisi che aspettavano soltanto qualcuno che se ne assumesse la paternità. Il primo è che ad un movimento sindacale con enormi ritardi da colmare quanto ad esperienza di libertà ed autonomia fosse saggio concedere la chance di costruirsi la sua al di fuori di schemi regolativi prefabbricati all’esterno e calati dall’alto.
Come dire: lungi dal piangersi addosso per le speranze suscitate dall’art. 39 e andate deluse, l’inattuazione della norma va caldeggiata in nome della stessa democrazia, scommettendo sulla voglia del sindacato di imparare a camminare senza stampelle legali. Pertanto, Giugni era più interessato a valorizzare la felix culpa di governi, Parlamenti e sindacati recalcitranti ad attuare l’art. 39 che a sfidare il legislatore a cimentarsi nell’attuazione di un progetto non memo ambizioso della quadratura del cerchio. Questo giurista, però, non sarebbe diventato l’opinions leader di intere generazioni se la scissione della Cgil non avesse ostacolato l’unità d’azione sindacale meno, molto meno di quanto prevedevano o auspicavano in molti. Certo, aveva impedito l’attuazione dell’art. 39, ma il pluralismo sindacale non equivale di per sé a dis-unità.
La rottura, che si consumò nel 1948 per effetto (come ho già detto) della pressione di fattori esogeni ed eventi esterni cui si deve il fatto che quella sindacale sia una storia minore, è figlia della “guerra fredda”. Però, il pluralismo sindacale che ne conseguì vide a poco a poco scolorirsi la valenza politico-ideologica della sua origine e si tramutò in patriottismo d’organizzazione. Il quale, se accentua l’identità di gruppi intenzionati ad atteggiarsi come distinti competitori, tuttavia non ne offusca la consapevolezza che una vitale comunione d’interessi li costringe a comportarsi da carissimi nemici. Dovendo contrattare con la medesima controparte, non possono non capire che l’unità d’azione è la sola condizione che permette di stabilire un rapporto di potere meno sperequato di quello raggiungibile separatamente e dunque più vantaggioso per i destinatari finali della contrattazione. Il che, al tempo stesso, si traduce in un aumento della profittabilità del servizio consistente nel predisporre le costose infrastrutture senza le quali i negoziati non potrebbero nemmeno cominciare.
Quella del sindacalismo del dopo-guerra – sostiene infatti Giugni intervenendo al Convegno di studi organizzato dalla Cgil per festeggiare nella scuola di Ariccia il suo 30° compleanno – è “la storia di come sia cresciuta all’interno di un sistema pluralistico una condizione, se non anche un progetto, di unità sindacale. (…) Gli anni dal ’60 al ’70 io li vedo come gli anni in cui l’unità sindacale è nei fatti”. Giugni inforca occhiali con le lenti giuste: l’evoluzione del diritto sindacale era governata da una stabile coalizione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative che, per un attimo, negli anni ’70 sembrò addirittura in procinto di trasformarsi permanentemente in una federazione unitaria. Se agli studenti ne parlavo come di un club elitario ed esclusivo, Piero Boni, che è stato il n. 2 della Cgil ai tempi di Luciano Lama, ne parlava come della “quarta confederazione senza nome e senza bandiera”.
La terminologia è troppo fantasiosa per poter essere adottata dalla Corte costituzionale, ma è questa l’impalpabile entità che la stessa Corte non esita a sponsorizzare come freno delle logiche aziendalistiche che disgregano l’intero e spezzano la coesione delle larghe solidarietà d’interessi di cui il club è espressione. Non diversamente, anche Giugni è fiducioso sulla propensione dei sindacati a trattenersi dal farsi rovinosi sgambetti, perché sa che l’unità d’azione ha finito per acquistare una valenza para-costituzionale in quanto è valutata dagli stessi sindacati un succedaneo della mancata applicazione dell’art. 39. Nell’occasione poc’anzi menzionata lo ascoltai, non senza sorpresa, esprimersi così: “vi è oggi la possibilità – che in precedenza non c’era – di ricostruire intorno ad un filo unitario la vicenda complessa delle varie confederazioni”. Forse, giudicava già allora un anacronismo la molteplicità di strutture confederali, vedendovi il retaggio di un sistema politico retto su pregiudiziali discriminatorie di cui si augurava il tramonto. Viceversa, l’ottimistica previsione sarebbe stata smentita dallo sgretolarsi dell’unico argine di contenimento del processo di de-costituzionalizzazione del sistema sindacale.
Difatti, lo smottamento produrrà situazioni ad un passo dall’anti-costituzionalità che minacciano la stessa libertà sindacale di cui con le regole di un gioco durato per mezzo secolo si voleva celebrare l’apologia. È la stagione degli accordi separati. Essa tocca il suo culmine con l’inaspettata eterogenesi dei fini subita dalla norma-cardine della legislazione di sostegno. Riformulato nel 1995 da un improvvido legislatore popolare allo scopo di allargare la cerchia dei sindacati con diritto di cittadinanza in azienda, nella Fiat di Sergio Marchionne l’art. 19 dello statuto dei lavoratori si trasformerà nel suo contrario: ossia, in un meccanismo di esclusione della Fiom di cui nessuno può contestare la rappresentatività. Infatti, il rischio da neutralizzare è quello che l’interpretazione letterale dell’art. 19 determini non più il rigonfiamento artificioso dei soggetti ammessi nell’area del privilegio legale per iniziativa e nell’interesse dell’imprenditore, bensì l’estromissione di chi ha diritto di starci.
Per questo, nel 2013 l’Alta Corte si pronuncerà nel senso che, come la sottoscrizione formale e meramente adesiva al contratto non è sufficiente a fondare la titolarità dei diritti sindacali, così la mancata firma non può produrne la perdita. Diversamente, si legittimerebbe “una forma impropria di sanzione del dissenso che incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato” di dire no, se lo ritiene necessario. Al tempo stesso, l’atteggiamento consonante con l’impresa verrebbe premiato anche a scapito dei lavoratori cui è negata la libertà di scegliere la rappresentanza che vorrebbero.
5. Uomo di idee semplici e passioni forti, Luciano Lama una volta disse che i sindacati sono come i castori: li guardi da lontano e ti sembra che non stiano facendo niente; poi, all’improvviso ti accorgi che hanno tirato su una diga. La medesima immagine mi è tornata in mente quando ho visto il monumentale immobilismo dei sindacati nei confronti dell’art. 39 interrompersi nell’arco del triennio, tra il 2011 e il 2014, durante il quale si sono svolte con la massima discrezione e pause sapienti le trattative del trittico interconfederale denominato, alla fine, Testo Unico sulla rappresentanza sindacale.
Confesso che la sua sottoscrizione mi colpì perché mi ero ormai persuaso che tra la posizione di chi ne aveva subito o sollecitato il rinvio dell’attuazione dell’art. 39 come una realistica necessità e quella di chi voleva farne lo strumento che consentisse di rimuovere definitivamente la questione, avesse finito per prevalere la seconda. Meglio tardi che mai, mi sono detto, prendendo atto con soddisfazione che il sindacato riconosceva di non poter continuare a sottrarsi a verifiche riguardanti il fondamento della sua legittimazione a partecipare da protagonista a processi di produzione di norme valevoli nei confronti di moltitudini di cittadini che non gli hanno conferito alcun mandato rappresentativo. Infatti, con la sottoscrizione del trittico interconfederale il sindacato ha promesso, anzitutto a se stesso, di non lasciarli più nella condizione di non sapere chi rappresenta chi né come possano essere regolati i dissensi inter-sindacali per evitare che diano luogo a traumi destabilizzanti; chi è legittimato a contrattare, con quale efficacia e quale responsabilità nei confronti della controparte e dei rappresentati.
A tutti questi interrogativi il corposo documento del 2014 fornisce indubbiamente risposte (o principi di risposta). Però, è presto per dire che esageravo a ritenere insuperabili le resistenze ad attuare l’art. 39. Infatti, la sottoscrizione del maxi-accordo non ne comporta l’immediata operatività. Il cantiere è ancora aperto e il completamento di questo work in progress procede a rilento: può persino darsi che si sia arrestato e, comunque, i pochi che sanno non parlano.
Come dire che l’art. 39 continua a spaventare. Però, fa più paura l’intenzione manifestata dai più recenti governanti di stabilire il salario minimo legale. Una misura del genere metterebbe fuori gioco la contrattazione nazionale, in pericolo la stessa esistenza dell’organizzazione ed a nudo il suo sovra-dimensionamento. Non per caso, la stessa Cisl sembra essersi allontanata dalla originarie posizioni anti-legalitarie che indussero i suoi deputati ad uscire dall’aula per non votare il primo provvedimento legislativo col quale gli imprenditori si videro revocare la licenza di licenziare. Secondo loro, la legge era un’indebita invasione di campo.