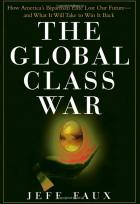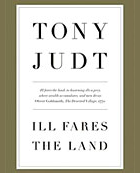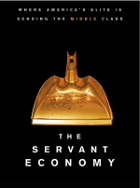Institutes |
La solitudine del lavoro
Sottotitolo:
L'attuale crisi del lavoro è diversa dalle precedenti perché enfatizza la subalternità del diritto del lavoro al punto di metterne in gioco la stessa esistenza.
I contendenti si risparmierebbero di dirsi delle sciocchezze se, pur contrapposti su tutto il resto, i loro discorsi partissero da una premessa comune. Con le cadenze di un sillogismo, essa si compone delle seguenti proposizioni: il capitalismo è all’origine di un incessante processo di trasformazione punteggiato da eventi che siamo soliti definire crisi del sistema economico; il diritto del lavoro è figlio del capitalismo; ergo, le crisi del capitalismo sono il suo abituale compagno di viaggio. Per scomodo che fosse, di lui il diritto del lavoro non ha mai potuto sbarazzarsi completamente, perché il rigido regime patriarcale in cui gli è toccato crescere non glielo permette. Anzi, gli ha insegnato a metabolizzare il vincolo subordinatamente al quale il lavoro dipendente, uscendo dalla zona grigia del pregiuridico, ha acquistato la facoltà di prendere la parola e farsi sentire: il vincolo consiste nel divieto di alzare troppo la voce. Tuttavia, la sua docilità è più apparente che reale: ricorda quella dell’enigmatico protagonista dell’apologo col quale Bertoldt Brecht ha celebrato l’elogio dell’umiltà che orgogliosamente fronteggia la tracotanza. “Un giorno nell’appartamento del signor Egge entrò un agente che gli mostrò un certificato emesso in nome di coloro che dominavano la città sul quale era scritto che doveva appartenergli ogni abitazione in cui mettesse piede e parimenti doveva servirlo ogni uomo che vedesse. L’agente si sedette su una seggiola, domandò da mangiare, si lavò, si coricò e, prima di addormentarsi, chiese: ‘Mi servirai?’ Il signor Egge lo coprì con una coperta, scacciò le mosche, protesse il suo sonno e, come in quel giorno, gli obbedì per sette anni. Ma, qualsiasi cosa facesse per lui, ce n’era una che si guardava bene dal fare: rispondere alla domanda. Quando, diventato grasso a furia di mangiare, dormire e comandare, l’agente morì, allora il signor Egge lo avvolse in un lenzuolo, lo portò fuori della casa, lavò le stanze, tinteggiò le pareti, diede un sospiro di sollievo e rispose: ‘No’”. Anche quello tra diritto del lavoro ed economia capitalistica è un rapporto di dominio. Esso però non è percorso unicamente dall’irriducibile conflitto latente che alimenta la sorda resistenza del dominato. E ciò perché tutti, un po’ alla volta, hanno capito bon gré mal gré che il dominio su di lui sarebbe durato molto di più dei sette anni inflitti al signor Egge e si sono stufati di contare quelli che mancano alla sua fine. Infatti, quando lo si è capito, si è cominciato ad imparare come il diritto del lavoro possa stabilire l’accettabile equilibrio che non c’era. Come si è saputo e potuto, ci siamo riusciti, sottoponendolo però ad un processo di mutazione genetica che lo ha trasformato. Se all’inizio non era altro che una normativa privato-individuale che regola uno scambio di mercato, diventerà in fretta un complesso di regole elaborato col consenso di rappresentanze collettive a base volontaria legittimate a partecipare alla costruzione di un ordine sociale che gli individui, non potendo né sceglierlo né rifiutarlo, uti singuli potevano soltanto subire e interiorizzare. Non era poco, ma non poteva bastare. Infatti, non tarderà a diffondersi la persuasione che l’autoregolazione sociale fosse un mezzo inadatto a realizzare i valori di cui è portatore il lavoro, anche quelli extra-patrimoniali. Dopotutto, il lavoro non aveva bussato alla porta della storia giuridica esclusivamente per essere rinchiuso dentro il recinto del diritto dei contratti tra privati e farsi catturare nella rete delle sue categorie logico-concettuali. Per questo, il diritto che dal lavoro prende nome e, almeno in parte, anche ragione non nasconderà la voglia di compiere un salto di qualità. Il che, però, sarà possibile solamente quando il lavoro senza aggettivi si isserà fino alle zone alpine del diritto costituzionale e lì si insedierà stabilmente come elemento fondativo della Repubblica. Per il diritto del lavoro il riposizionamento segnava un nuovo inizio e perciò avrebbe obbligato a ripensare il referente antropologico del suo paradigma regolativo. Adesso, il primato non spetta più allo stato occupazionale o professionale: è passato allo stato di cittadinanza garantito da una democrazia costituzionale indipendentemente dalla variabile tipologia dei lavori e tanto dall’esistenza quanto dall’attualità dei relativi rapporti giuridico-contrattuali confezionati per ciascuno di essi. Il lavoro è tuttora il passaporto più richiesto per accedere alla cittadinanza intesa come formula riassuntiva dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ai consociati. Ma vede accentuarsi il suo ruolo strumentale, perché lo status di cittadinanza lo sostituisce come prius generatore delle aspettative di un’esistenza dignitosa e criterio di misura della loro adeguatezza al tempo presente. L’itinerario che ho fin qui cercato di sunteggiare non era neanche immaginato dai giuristi del lavoro del primo ‘900, convinti che il diritto del lavoro fosse una tecnica di disciplinamento delle condotte individuali in conformità alle esigenze delle macro-strutture massificanti e totalizzanti della produzione industriale, pur senza rinunciare ad ingentilire l’etica degli affari. Di strada quindi il lavoro dipendente ne ha fatta tanta. Segnatamente nel secondo dopoguerra. Ed ha potuto farla soprattutto perché si giovava di una rappresentanza bicefala. Appunto per questo appariva a molti debordante. E’ innegabile, però, che fu questa sovra-rappresentanza a dargli il carisma e la forza necessari per competere col capitale in una lotta cui entrambi partecipavano con l’ingenua credenza che l‘eliminazione dell’avversario avrebbe soddisfatto l’interesse generale. Guardando quel che sta capitando ora, si direbbe che da una forma di rappresentanza a struttura binaria il lavoro dipendente è transitato ad una sotto-rappresentanza rissosa che insegue problematiche distanti dai bisogni reali. Infatti, ormai orfano della rappresentanza politica gestita dai defunti partiti della sinistra, attualmente dispone di una rappresentanza sindacale lacerata da tensioni anti-unitarie che la indeboliscono. Insomma, sinistra politica e sindacati sono entrati in un cono d’ombra proprio durante una crisi economica di drammaticità non inferiore a quella della situazione d’emergenza che ne determinò la nascita e l’affermazione. La crisi attuale è diversa dalle precedenti perché enfatizza la subalternità del diritto del lavoro al punto di metterne in gioco la stessa esistenza. Il fatto è che esso si era evoluto a misura dell’icona novecentesca in cui Massimo D’Antona a ragione vedeva riprodotti i lineamenti di “colui che è assunto per lavorare stabilmente con vincolo di orario pieno, negli ambienti produttivi del datore di lavoro, alle dirette dipendenze di superiori gerarchici, soggetto a penetranti controlli e punito con sanzioni se colto in fallo, retribuito a ora o a mese, sindacalizzato e aduso a scioperare”. Di questa figura oggi si pretende e s’invoca la sostituzione con quella, già in fase di gestazione, non tanto del cittadino cui la costituzione riconosce il diritto al lavoro quanto piuttosto dell’uomo flessibile, del lavoratore usa-e-getta, del soggetto funzionale alle esigenze di un mercato globale e concorrenziale. Durante il secolo XX, invece, era stato coronato dal più ampio successo lo sforzo di creare con ostinazione feroce e, diceva Antonio Gramsci, con “una coscienza del fine mai vista nella storia (...), un tipo nuovo di lavoratore e di uomo”, educato a giudicare assolutamente normale, naturale e anzi doveroso che “tutti si alzassero alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui (...) e la vita lavorativa si svolgesse per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione”. Difatti, quello del lavoro è diventato il diritto del secolo perché il ‘900 è stato, come recita il titolo di un bel libro di Aris Accornero, “il secolo del lavoro”; un lavoro che non si declinava al plurale, un lavoro-standard. Per questo, la radicalità del cambiamento imposto dal capitalismo per uscire dalla crisi attuale rimanda alla stagione delle macerie della proto-industria che permise l’avvento della prima modernità. Come dire che Cipputi e i suoi nipotini stanno sopportando il peso di una crisi epocale di cui non sono responsabili e, ciononostante, sono costretti a pagare il prezzo più alto. Non diversamente, peraltro, dai loro lontani antenati. Tutto sommato, però, erano meno soli di Cipputi e i suoi nipotini. Anche per questo, il diritto del lavoro rischia di vedersi immesso in un circuito circolare destinato a riportarlo al punto di partenza. Umberto Romagnoli
Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight. |